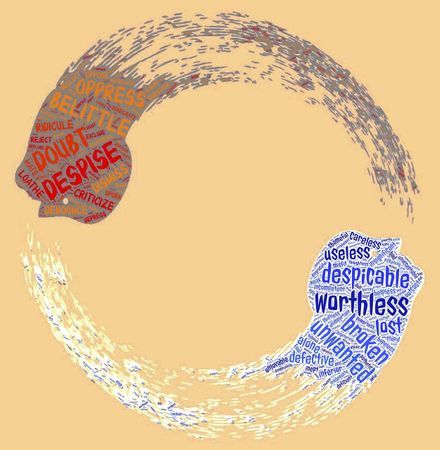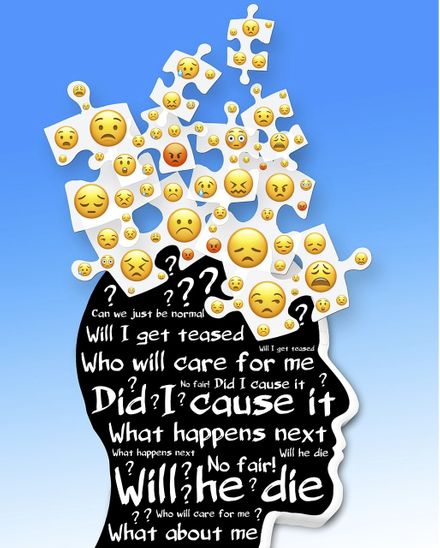I miei articoli scritti e pubblicati nel 2017
Scritti e pubblicati per il quotidiano online Rosso Parma nella rubrica da me realizzata e curata Counsleing con Ciabattoni Letizia
Se vuoi leggere gli altri clicca qui sotto
Counseling con Ciabattoni Letizia: la gentilezza e i suoi benefici soggettivi e sociali
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 23 December 2017
Il 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza. Se tanta importanza viene affibbiata ad una condizione quale l'essere gentile, ve ne saranno degli ottimi motivi e propositi non solo individuali ma anche sociali. Quando fai qualcosa, qualsiasi cosa, che esso sia un gesto o una parola gentile per qualcun altro, ci si senti bene, solitamente. Gli atti di bontà gratuita, sono spesso accompagnati da mero “calore” emotivo, il quale produce l’ormone ossitocina, che provoca il rilascio di una sostanza chimica chiamata ossido nitrico nei vasi sanguigni, che ha la funzione di dilatare i vasi sanguigni, riducendo così la pressione sanguigna e proteggendo il cuore. Ecco perché esternare altruismo, tolleranza, disponibilità è a tutti gli effetti un vero e proprio passo importante per proteggere la salute del nostro cuore oltre a quello della nostra mente. Ma non finisce qui: una ricerca mostra che l’ossitocina, riduce i livelli di radicali liberi e l’infiammazione del sistema cardiovascolare rallentandone così l'invecchiamento alla fonte. A livello sociale e relazionale possiamo asserire fermamente che a chiunque piacciono le persone che mostrano gentilezza nei nostri confronti. Questo perché la gentilezza riduce la distanza emotiva tra due persone e così ci si sente più “legati”, collaborativi. Vi sarete accorti che spesso e volentieri gli altri ci ispirano a essere gentili, creando una sorta di catena della gentilezza. Proprio come una pietra gettata in uno stagno, la gentilezza crea un susseguirsi di onde sulla superficie dell’acqua, estendendosi verso l’esterno, toccando la vita altrui in maniera propositiva. Chi è gentile sa essere aperto e rispettoso, dimostra tolleranza e ascolto verso gli altri e conosce i valori dell’affidabilità e della reciprocità. Khalil Gibran ha scritto che: “tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione“. La gentilezza è correlata al benessere, alla resilienza, alla creatività e alla stabilità relazionale. Chi matura un atteggiamento positivo incondizionato e realistico, nei confronti degli altri, è più resistente agli eventi critici del ciclo di vita e ha più probabilità di maturare i propri talenti e realizzare obiettivi personali e professionali. Essere gentili non è, come si crede, più complesso dell’essere insolenti. Espressioni come “Grazie”, “Posso aiutarti?”, “Offro io”; azioni come una telefonata a un amico in difficoltà, fare un complimento a qualcuno, far passare la fila al supermercato a chi, dopo di noi, ha un solo articolo, sono solo esempi di piccolissime azioni, che possono riportarci al valore della gentilezza e favorire il nostro benessere. Potrebbero sembrare inezie, ma sono i semi della gentilezza, e conviene piantarli: sono resistenti e attecchiscono in ogni terreno, a qualsiasi età, a volte è solo una questione di tempo. Parola di Counselor! Colgo l'occasione per fare i miei più sentiti auguri di buon Natale e per un inizio di anno tutto effervescente e all'insegna della crescita personale. Un periodo di riposo è necessario affinché chi scrive e chi legge possa metabolizzare le informazioni dei mesi scorsi e soprattutto possa dedicarsi alla centratura di sé. Ci ri-leggeremo puntuali, ogni sabato, tra un paio di settimane. Grazie per questo anno trascorso assieme! Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: la fine di una relazione ci fortifica, aumenta la nostra resilienza
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 16 December 2017
Non si tratta di un semplice detto popolare: “quello che non ci uccide ci fortifica”, ma anche il risultato di uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, in cui si afferma che gli eventi avversi della nostra vita, come lo potrebbe essere la fine di una relazione di coppia più o meno duratura, aumentano la nostra capacità di resilienza e ci aiutano a migliorare il nostro atteggiamento mentale verso la vita, regalandoci preziose occasioni di crescita ed evoluzione. Con la fine di un matrimonio, di una convivenza, ci possiamo sentire abbandonati, temere la solitudine, sentirci minati nella nostra autostima e cosa ancor peggiore, non avere più fiducia nell'amore, nel prossimo che incontreremo e che potrebbe nuovamente farci battere il cuore. Certe volte, la rottura di una relazione potrebbe portarci a comprendere cose di noi stessi che sarebbe utile conoscere prima di incappare in una nuova storia. Accettare che la coppia, qualsiasi essa sia, è imperfetta, che non dovrebbe essere idealizzata e tantomeno dovrebbe soffocare il nostro essere un individuo libero di scegliere e realizzarsi sarebbe già un gran passo in avanti. Nelle future storie impareremo a considerare la possibilità che sia umano fallire e che alcuni meccanismi del rapporto potrebbero indurre noi stessi o il partner a sbagliare. L'esperienza vissuta può servire a riconoscere ciò che non va, imparare a prevenire e non far accadere ciò che è successo nel passato. Una esperienze traumatica come quella di una separazione e di un divorzio potrebbe esser utile a porci delle domande su cosa per noi, è o meno importante in una coppia? Chi vorremmo al nostro fianco? Quanto siamo disposti a lasciar correre scendendo a compromessi e a cosa proprio non rinunceremo mai più? Saremo ancora in grado di lasciarci andare e buttarci in una nuova storia d'amore? Non sempre è facile riaprire il capitolo della propria vita sentimentale, tantomeno concedersi il lusso di un flirt, ancor peggio se vi sono dei figli in ballo. Di certo una separazione necessita del giusto tempo per essere rielaborata, digerita, superata. Riemergere dalle macerie di un rapporto perduto, fallito, ci porterà ad essere molto cauti in una nuova storia per cercare di controllare le nostre emozioni, le nostre paure, i dubbi, temendo che ci si invischi a capofitto solo per non sentire il senso di vuoto e solitudine. La cosa importante sarebbe quella di riuscire a focalizzarsi su se stessi e non fare in modo che l'altro o l'altra diventino il perno a cui tutto il mondo ruota attorno. Imparare a fidarsi della nostra capacità di scegliere e sentire, ad ascoltarci per capire cosa davvero desideriamo. L'altro dovrebbe poter essere un valore aggiunto nella nostra vita in quel preciso momento, senza avere la pretesa di fare investimenti a lungo termine e, soprattutto, senza caricarlo di responsabilità che appartengono a noi e noi soltanto. Non acceleriamo i tempi, concediamoci intimità con noi stessi, assaporiamo il tempo in solitudine con la nostra persona, i nostri spazi e godiamoci il corteggiamento senza voler arrivare ad una “concretizzazione” della storia ad ogni costo. Restiamo nel presente con la consapevolezza che un amore può essere eterno anche in un solo giorno. Godiamo del momento presente, delle nostre emozioni, imparando a riconoscerle, a dare loro un nome e quindi a gestirle senza farci travolgere. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: riequilibrare mente e corpo in una unica sinfonia
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 08 July 2017
Notte e giorno, luna e sole, bene e male, femminile e maschile… polarità interconnesse tra loro, ben individuate da molti, se non da tutti, ma allora perché ancora oggi, risulta così difficoltoso ri-conoscere la stretta correlazione tra mente e corpo. Molto spesso siamo “prigionieri” delle nostre stesse “gabbie” mentali, ci lasciamo gestire dagli eventi, tarpiamo le ali alle nostre emozioni oppure ne siamo totalmente in balia sino allo sfinimento. Molti miei clienti, dopo alcuni incontri di Counseling, mi raccontano dei lori mal di pancia prima di una cena a casa dei suoceri, di notti insonne post discussione con il partner, di mal di testa improvvisi e assolutamente martellanti durante i tanto anelati weekend dopo una tediosa settimana lavorativa. Tralasciando tutti quelle patologie strettamente correlate all’insorgenza di virus o batteri e molto altro ancora, proviamo a focalizzarci su tutti quei “fastidi” ricorrenti che hanno spesso e volentieri una stretta correlazione con il nostro sistema emotivo e relazionale. Non vi è ormai alcun dubbio sul fatto che il filo d’Arianna tra la maggior parte dei disequilibri tra il dualismo mente-corpo non è altro che l’immagazzinamento e l’accumulo di cariche emotive negative nelle memorie cellulari. Svariate ricerche sul campo hanno dimostrato che ogni nostra emozione lascia una traccia, un negativo impresso, registrato nelle nostre cellule sotto forma di memoria indelebile o quasi. Queste forme di memoria influenzano le nostre relazioni, il nostro modo di comportarci e di reagire allo stress, alle tensioni, alle sfide emotive che si presentano nella nostra vita o al raggiungimento degli obiettivi tanto bramati. Quando il nostro potenziale si percepisce soffocato, si creano, senza che spesso ce ne accorgiamo, delle vere e proprie trappole che potrebbero, alla lunga, farci ammalare o far sì che alcuni comportamenti da noi sviluppati ci arrechino sofferenze. Il corpo ci lancia innumerevoli campanelli di allarme sullo stato emotivo che sta prendendo il sopravvento, bisognerebbe essere più solerti nell’imparare ad ascoltarlo e prendersi cura di noi stessi a 360 gradi, non solo con una sana alimentazione, con della giusta attività fisica e del buon riposo ma anche imparando a rilasciare le emozioni negative. Impariamo ad abbandonare tutto ciò che non ci permette di sfruttare al meglio il nostro illimitato potenziale come esseri umani e di avere una vita più sana e completa. Impariamo a prenderci cura di noi stessi fisicamente ed emotivamente, liberandoci dal controllo e dal condizionamento del passato. Abbiamo bisogno di ri-scoprire quelle parti positive di noi che sono state soffocate dalla carica emotiva negativa e di risolvere i nostri conflitti interni e relazionali, recuperando e ripristinando la nostra energia vitale. Un buon lavoro su noi stessi consiste quindi nel riconoscere, in primis e poi, liberare il nostro corpo da tutte le corazze e le armature fisiche e mentali che ci impediscono di sentire noi stessi in maniera autentica, entrando così in contatto con emozioni profonde e recuperando una gran quantità di energia vitale. Liberando il nostro corpo dalle emozioni trattenute dovute a traumi, crisi di varia natura vissuti nell’arco della nostra vita, dando al nostro corpo nuove sensazioni positive, nuovi stimoli valoriali, daremo ad esso la possibilità di registrare nuove energie positive al posto di quelle vecchie e negative. Una sorta di ri-programmazione del nostro hardware, precedentemente attaccato da un bug corrosivo, con l’ausilio di un nuovo sistema antivirus aggiornato in modalità positiva e consapevole. Concediamoci uno spazio nel quale rielaborare i dati in maniera del tutto consapevole, in un contesto del tutto protetto e senza doverci condannare ad una vita angusta ed esclusivamente in salita per timore di non meritare altro. Liberiamoci della parte “tossica” di noi stessi che ci ha comunque permesso di consapevolizzare il malessere percepito. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: come trasformare il proprio giudice interiore in un alleato fidato
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 21 July 2017
Quanti di noi non hanno mai commesso un errore e per salvaguardia personale si sono giustificato alla meno peggio? Molti altri invece, probabilmente, non accettano di fare passi falsi e quindi non ammettono assolutamente di aver sbagliato. Infine, ci sono alcuni, tra noi, che sono ipercritici verso loro stessi, fustigandosi e accollandosi ogni sorta di piccolo sgarro. A metterli in evidenza, i nostri errori e non solo quelli, ci pensa il dito puntato instancabile del nostro giudice interiore, vigile quasi perennemente delle nostre esistenze. Molti miei clienti affermano di identificare il giudice interiore come una enorme figura ingombrante che li vorrebbe perfetti. Alcuni di loro mi dicono di ascoltarlo, altri che lo alimentano e che si lasciano da lui condizionare l’intera esistenza. Darci la colpa nel momento in cui commettiamo un errore, come prima reazione, è un meccanismo normale che ci consente di imparare, se restiamo entro i limiti della autocritica. In caso contrario potrebbe talvolta innescarsi un desiderio più o meno consapevole di autopunirsi. Quando proviamo vergogna o ci sentiamo sviliti, è perché il giudice interiore sta puntando il dito contro di noi. Ma allora di cosa stiamo parlando? Di un amico o di un nemico? Partiamo dal presupposto che non per forza trattasi di una figura abominevole uscita dagli inferi. Il giudice interiore amico, elabora e dà un feedback coerente e incoraggiante, cerca di innescare migliorie allineate con le nostre reali esigenze e affini alle nostre capacità. Un giudice interiore amico ci rende propositivi, forti, pronti a progredire e autoconsapevoli delle nostre capacità reali. Per contro, il giudice interiore nemico ci dà standard improponibili e difficili (se non impossibili) da rispettare. Nei casi più estremi è pronto a puntare il dito sul nostro operato senza badare né a circostanze né alla fattibilità dei suoi standard. Così ci ritroviamo a pensare a un miliardo di: “DEVO fare più attività fisica, DEVO studiare di più, DEVO essere più preparata, DEVO fare di meglio.” In poche parole, un giudice interiore nemico ci fa sentire vittime delle vita e delle circostanze, può renderci aggressivi, ricchi di pregiudizi verso noi stessi e gli altri, prevaricatori, colpevolizzanti ma anche auto-punitivi e costantemente insoddisfatti di noi. Ma allora come si potrebbe trasformare questo nemico in un mero alleato e per giunta di fiducia? Innanzitutto va riconosciuta la sua presenza e il suo ruolo in noi stessi e nelle nostre vite, dopodiché impariamo a capire e ad accettare che la costante auto-condanna o auto-recriminazione che la si voglia chiamare, non è utile per nessuno e può portare all’interno a dei buchi neri dai quali potrebbe risultare, alla lunga, molto difficoltoso risalire. Quindi fomentiamo la nostra autostima, inversamente proporzionale alla severità del nostro giudice interiore. Più alta sarà la nostra autostima e più complice e amico sarà il nostro g.i.. Lavoriamo quindi sulla cura dell’autostima. Un altro aspetto fondamentale da tener bene in mente è quello di imparare ad assumere prospettive e punti di vista del tutto nuovi e differenti dal nostro abitudinario schema mentale sull’agito. Il punto di vista che abbiamo su noi stessi corrisponde, spesso e volentieri, a ciò che pensa il nostro giudice interiore, nonostante egli non sia il depositario della verità assoluta. Se proprio risulta così difficile assumere autonomamente un differente punto di vista su noi stessi, parlarne con un amico o con un professionista potrebbe essere un ottimo compromesso. Un’altra buona strategia consiste nell’immaginare che dentro di noi alberghi un bambino molto piccolo da curare tramite il dialogo interiore evitando di dire qualcosa che potrebbe ferire quel bambino; esercitiamo la nostra auto-compassione, ad essere gentili con noi stessi. Gestiamo i sensi di colpa con la consapevolezza l’accettazione del fatto che in un determinato momento, un determinato errore, potrebbe essere stato dettato da conoscenze e circostanze del “là ed allora”, mentre dovremmo focalizzarci sul “qui ed ora”, sul presente attivo. Robetta non da poco, ma del tutto fattibile anche grazie a dei piccoli esercizi di meditazione guidata rivolti a imparare a familiarizzare con sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni. Bisognerà lavorare molto sulla autoconsapevolezza, grazie alla quale possiamo capire realmente il nostro valore e il valore reale dei nostri errori. Infine, un po’ di autocritica non guasta mai, anzi potrebbe risultare essenziale per poter migliorare, basta fare in modo che sia sempre costruttiva e non auto-colpevolizzante. Ricordiamo che l’autocritica distruttiva non fa altro che abbassare ulteriormente la nostra autostima e irrigidire il nostro giudice interiore che è sempre in agguato, pronto a riprendersi scettro e trono ma i re e le regine delle nostre vite siamo noi e noi soltanto. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: sfogare la rabbia fa bene ad adulti e bambini
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 30 June 2017
La rabbia è una emozione del tutto naturale, potremmo provare a considerarla una “sana aggressività” che ci infonde energia, una energia che andrebbe scaricata, al fine di evitare ansia e malattie psicosomatiche del tipo: cefalea pulsante: nella quale l’aggressività cerca di uscire martellando il cervello; tensione muscolare: in questo caso i nostri muscoli si controllano per non aggredire; bruciori di stomaco: accade perché la rabbia inespressa lavora dentro e ci corrode; eczema alle mani: sembra una mera espressione metaforica “le mani mi prudono dalla voglia di usarle” e le varie malattie del fegato, all’interno del quale la rabbia si deposita. Evitare tutto questo si può, basta lasciar sfogare la rabbia, con gesti forti ma innocui, come strappare alcune pagine di un giornale o prendere a pugni un cuscino, meglio ancora se ci si ritrova soli a poter urlare ai quattro venti le proprie ire. Ma non sempre la risoluzione più consona al momento è quella dello sfogo, sia per il contesto sociale in cui ci si ritrova che per evitare di ferire inutilmente chi ci ritroviamo davanti. In questo caso, provare ad osservare la rabbia, affidandosi a lei, disidentificandoci da lei in quanto emozione e non noi stessi, potrebbe essere un’ottima risoluzione. Partiamo dal principio di ammettere in maniera molto easy “io sono arrabbiata, lo sono in maniera del tutto disgiunta da una persona o un evento predeterminato. Semplicemente provo questa scarica di ira che mi pervade, respiro, la osservo”. E per quanto concerne il bambino? Quella idilliaca fase della vita senza preoccupazioni e responsabilità. Errato, forse a guardarci bene dentro, le cose sono un po’ differenti, se partiamo dal presupposto che da piccoli si hanno ben poche libertà, sono sempre gli adulti (genitori, nonni, educatori, insegnanti, catechisti…) a decidere orari, pasti, vestiti, giochi…evidentemente molto lo si fa per il loro bene e per la loro stessa tutela personale, ma tutta questa privazione di libertà contrasta frequentemente con i desideri, gli istinti e le pulsioni dei bambini. Molti genitori ricorderanno bene la “fase dei no” (2 anni circa), fase in cui i bambini provano ad esprimere loro stessi in maniera oppositiva, testando limiti propri ed altrui. Ma come possiamo disinnescare le crisi di rabbia dei bambini? Innanzitutto proviamo ad avvertirli un po’ prima del cambio di attività, contesto, facendo percepire loro in modo meno imperativo le nostre richieste, anche se del tutto legittime tra le altre cose. Donna mamma sgrida bambino sfondo tramontoMa una volta che la bomba si è innescata, possiamo provare ad evitare alcuni errori tipici: una punizione in piena crisi, in cui il bambino perde il controllo di sé è frustrante e non funzionale poiché da lui non compresa; lo stesso vale per delle spiegazioni troppo prolisse e filosofiche, sarebbero parole al vento poiché la capacità di ascolto è davvero scarsa; d’altro canto, ignorarlo totalmente lo farebbe sentire sminuito, incompreso, solo. Non perdiamo il controllo più di lui, evitiamo nella maniera più assoluta di prenderlo in giro e tantomeno “castriamo” la sua necessità di sfogarsi, nei limiti, ovviamente. Se ci fossero casi di pericolo estremo per lui e altri, sentiamoci autorizzati a bloccarlo fisicamente e a usare un tono fermo senza urlare. La signora Agata mi scrive: “ma allora dottoressa qualsiasi cosa io faccio non va mai bene, eppure io, quando ero piccola, prendevo due bei ceffoni e la piantavo lì. Sono io l’adulto e non lui, è lui che deve ascoltare me e non io che debbo assecondarlo. Con me ha funzionato, i miei non usavano tante parole, anzi…eppure. Mi dica lei dottoressa.” Carissima Agata, accogliamo la rabbia senza farci travolgere. Lasciamo sfogare il bambino, restiamogli vicino, in silenzio, senza cedere a richieste e ricatti, semplicemente aspettando che passi. Sbollita la rabbia parliamogli , chiedendo al bambino perché si è arrabbiato, aiutandolo a riflettere e a conoscersi meglio. Insegniamo altri modi di reagire, magari urlando meno o non correndo per tutta la casa. Facciamogli capire che in tal maniera non riusciamo a capire cosa stia dicendo, quando per noi è importante comprenderlo per poterlo aiutare. Restiamo calmi e non dimentichiamo mai di consolidare la fase di quiete dopo la tempesta con un abbraccio e un sincero “ti voglio bene!”. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: eliminare lo stress con il Counseling
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 15 July 2017
“Quanto avrei da raccontarLe, dott.ssa Letizia, in merito alle innumerevoli volte in cui mi sono sentita stressata al punto di voler mollare tutto e tutti. Mi riprometto sempre di non arrivare più a “livello” e di prevenire lo stress ed invece faccio una grande fatica a rallentare prima di inciampare. Una volta caduta mi dico che ormai ci sono talmente invischiata dentro che a risalire sarà dura davvero. Grazie, Anna”. Come ci fa notare Anna, arrivare a “livello” non è poi troppo difficile, poiché i cambiamenti, sia positivi che negativi, possono costituire una fonte di stress perché ci chiedono contemporaneamente di rinunciare a qualcosa di positivo e di aumentare le nostre responsabilità. Per cambiamenti positivi, quindi spesso e volentieri da noi stessi desiderati e voluti, si intendono ad esempio: l’organizzazione del proprio matrimonio, una gravidanza, una promozione sul lavoro o un esame importante. In tali circostanze positive, lo stress viene però presto compensato dalla soddisfazione che il cambiamento produce, trattandosi perciò di uno stress temporaneo. Ma quando abbiamo a che fare con cambiamenti negativi e da noi di certo non voluti, se non addirittura per noi inaspettati (un divorzio o un abbandono, un licenziamento, una situazione di mobbing, di abuso o di violenza, un periodo lungo di disoccupazione, un problema economico, la scoperta di una malattia grave, l’assistere un parente malato, la morte di una persona cara...), lo stress diventa insostenibile al punto tale da mettere in pericolo il nostro equilibrio psico-fisico. Quando parliamo di stress quindi, indichiamo uno stato di tensione associato spesso a malessere diffuso con conseguenze negative per il nostro organismo, il nostro stato emotivo e conseguentemente per le nostre relazioni con il mondo esterno. Richieste eccessive che provengono dall'ambiente circostante, potrebbero superare le nostre effettive capacità di adattamento ad esso, creando la possibilità, a lungo andare, di farci sentire letteralmente schiacciati dagli stimoli e, pur impegnandoci al massimo, renderci incapaci nel far fronte a tutti gli impegni da dover adempiere. Sono molte le avvisaglie psicosomatiche provenienti dal nostro corpo: l’aumento del battito cardiaco e della pressione, l'accelerazione del metabolismo, che il nostro corpo manifesta nelle situazioni stressanti, sino ad arrivare, nelle situazioni di stress cronico, a mere modificazioni ormonali, causa di stanchezza, dolori muscolari, caduta dei capelli, irregolarità mestruali, tachicardia, difficoltà digestive, intestino irritabile, diminuzione del sistema immunitario. Allora vale davvero la pena, cara Anna, ridurre lo stress dalle nostre vite se proprio eliminarlo del tutto non ci è possibile. Proviamo innanzitutto riscoprendo e rivalutando i nostri sensi: stimolare positivamente la vista leggendo un buon libro, andando a guardare una galleria d'arte impegnando così i propri sensi visivi con la pittura, l'arte in generale, provando a sognare ad occhi aperti attraverso visualizzazioni di immagini e/o ricordi piacevoli; per l'olfatto è utile godere di oli essenziali, candele profumate, dell'odore della natura, la salsedine del mare o l'odore dei boschi; risvegliare il tatto con l'attività fisica, usando una pallina anti-stress da strapazzare nelle proprie mani, suonare uno strumento musicale, farsi fare un massaggio rilassante; poi ascoltare, ascoltare i suoni di una dolce melodia, quelli della natura, ascoltare il proprio respiro durante una meditazione guidata; infine ricordare di usare la bocca per sorridere, cantare, ripetere a se stessi frasi positive ad alta voce, mangiare del cibo speciale e sano che possa gratificare in maniera soddisfacente senza abbuffarsi con l'intento di affogare frustrazioni e tensioni, usare la bocca per parlare con qualcuno che sappia ascoltare, un Counselor ad esempio. Un percorso di Counseling può aiutare ad analizzare il proprio stile di vita; a identificare le abitudini stressanti e a trovare le strategie per attuare piccoli cambiamenti. Certe volte basta davvero poco: guardare la propria quotidianità con occhi diversi per riuscire a trovare le strategie più efficaci per aumentare il benessere psicofisico. Piccoli cambiamenti attuati con consapevolezza e nei giusti tempi, possono portare alla diminuzione dello stress anche in tempi brevi. Un professionista può aiutare a semplificare la vita identificando le fonti di stress e cercando insieme al proprio cliente di eliminarle o diminuirle, stabilendo delle priorità, attraverso una migliore organizzazione delle attività quotidiane, mirando innanzitutto alla salute e al benessere. Nulla vieta di confrontarsi anche con persone a noi care che vivono o hanno vissuto la stessa situazione, una collega, un amico..ottime strategie che aiutano ad evitare l'isolamento al quale lo stress spesso induce. Impariamo anche ad ammettere a noi stessi di aver bisogno di farci coccolare, sostenere, senza per questo sentirci dei perdenti. Diminuire lo stress è possibile, ma bisogna essere disposti a mettersi in gioco nell'attuare alcune modifiche al nostro programma di sopravvivenza quotidiana. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: quando l’adolescente solitario denota un comportamento sano
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 24 June 2017
Molti genitori mi chiedono un parere in merito ai loro figli adolescenti “troppo spesso chiusi nelle loro stanze, soli, ascoltando musica e passando ore tra cellulari, social e tv, uscendo poco con degli amici reali”. Partiamo dal principio che il rapporto tra solitudine e adolescenza, non sempre ha una connotazione negativa a livello comportamentale. Molto di frequente, un adolescente che desidera trascorrere del tempo solo, mostra un buon adattamento estrinseco ed un elevato sentore di benessere intrinseco. Inutile negare l’esistenza di vissuti negativi correlati a momenti di solitudine delle persone, eppure, molte ricerche recenti possono documentare l’importanza del saper stare da soli. Corsano (2008) ci aggiorna sul fatto che è stato evidenziato un ruolo significativo della solitudine nel delicato processo di separazione-individuazione dalle figure genitoriali, in quanto, essa crea quello spazio fisico e mentale nel quale l’individuo che cresce può ritagliarsi un’autonomia di pensiero e di azione propria. È stato dimostrato che, durante questi momenti di intimità, l’adolescente riflette, rielabora le proprie emozioni, si rilassa e si rinnova. Stare da soli è uno, tra i tanti bisogni utili per una crescita personale solida, tanto quanto il bisogno di un sano attaccamento affettivo. Ai genitori che mi chiedono un parere in merito, rispondo spesso che occorre indagare la motivazione sottostante ad un comportamento “solitario” del proprio figlio adolescente, prima di poter attribuire una accezione positiva o negativa del concetto di stare in solitudine. L’adolescenza di per sé è una sorta di “tira e molla” tra il desiderio di conquistare l’autonomia nei confronti dei genitori e degli amici e quello di sentirsi accettato, conformato da quelle che sono le aspettative sociali provenienti dall’esterno. Scegliere di trascorrere del tempo da soli non necessariamente deve far scattare il campanellino d’allarme rosso: depressione. Molto semplicemente, da una parte, i ragazzi trascorrono volentieri del tempo in compagnia, nel contempo, lo star soli li aiuta a gestire i contrasti interni propri. È durante l’adolescenza che la solitudine diviene un sentimento che indica la capacità di riflettere su se stessi, di guardarsi dentro, di prendere consapevolezza dei cambiamenti in corso, abbandono delle certezze dell’infanzia e della fanciullezza senza averne ancora di nuove. Ben differente è invece il ritiro sociale da parte degli adolescenti, conosciuto da tempo ormai in Giappone con il termine Hikikomori: isolarsi, chiudersi, ritirarsi in maniera progressiva da ogni contesto sociale per paura di un confronto coi pari, rinunciando alla sana competizione con essi per paura di accumulare fallimenti, abbandono scolastico sino all’estrema auto-reclusione in casa o addirittura nella propria stanza. Distinguere quindi, un sano desiderio di solitudine con se stessi e in se stessi, da un mero ritiro sociale è decisamente un passo fondamentale da fare sia in ambiente scolastico che familiare per eventuali agiti da mettere in atto. Non sottovalutiamo il ritiro sociale nella maniera più assoluta, in egual misura riconosciamo il giusto spazio e tempo di solitudine ai nostri adolescenti. Z. Bauman dice: “Quando si evita a ogni costo di ritrovarsi soli, si rinuncia all’opportunità di provare la solitudine: quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie idee, meditare, riflettere, creare e, in ultima analisi, dare senso e sostanza alla comunicazione”. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: ottimismo e pessimismo, facce della stessa medaglia
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 17 June 2017
La mail di Ferdinando, 24 anni, studente in economia: “Salve dottoressa Letizia, scrivo perché spesso mi capita che gli amici in facoltà mi dicano che non ho mai mezze misure nel descrivere le cose, o sono totalmente ottimista o di contro sono puramente pessimista. Personalmente sono sereno, credo che le cose vadano valutate di volta in volta senza uno schema preciso e prefissato”. Come non essere in sintonia con Ferdinando. In effetti, ottimismo e pessimismo potrebbero essere ben identificati come le due facce della stessa medaglia, non è altro che una attitudine delle persone a valutare vicende personali, sociali, la crisi economica piuttosto che l’ondata migratoria e le sorti del planisfero. Le persone si distinguono spesso per il loro: “tutto andrà bene” o per quelle che: “c’è solo che da aspettarsi il peggio del peggio!”. La cosa più sorprendente sta nel fatto che non di rado gli ottimisti vengano identificati come degli illusi sognatori, superficiali a loro modo nel non saper analizzare con concretezza la realtà e le sue situazioni circostanziali, di contro vi sono gli schieramenti pro “think positive, be positive” che identificano l’ottimista come un soggetto positivo, inarrendevole dinanzi a qualsiasi ostacolo, fiducioso nelle proprie capacità e in quelle altrui. Cosa alquanto divergente per il pessimista, un guasta feste, l’uccellaccio del malaugurio che riesce sempre a far realizzare la disgrazia tanto temuta su lui e il resto dell’umanità. Tutte faccende populiste ma che poco hanno di scientifico. Insomma, né l’uno, né l’altro atteggiamento possono ritenersi utili ai fini di comprendere la realtà ed affrontare le sfide quotidiane. Aggrapparsi e ripetere allo stremo dei modelli di azione acquisiti in passato non è una buona strategia attuativa. Per apprendere del nuovo, per valutare nuove possibilità da adottare occorre arrestare il funzionamento ridondante dei vecchi schemi. Cosa fosse se si cercasse di restare il più possibile aderenti alla realtà, esaminando in maniera analitica le situazioni che si vivono? Certamente, mantenere la percezione ottimista di poter modificare le cose a proprio favore ed il percepirsi come validi ed efficaci può essere utile, non solo, andrebbe anche migliorato se possibile grazie ad esercizi di flessibilità del pensiero positivo. “Pensare positivo e sentirsi potenti”, non a caso viene adoperato in molti slogan. Personalmente ritengo che un atteggiamento di speranza e fiducia nella vita sia in grado di cogliere e canalizzare molte energie e risorse per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, a differenza di un atteggiamento pessimistico, il quale porta semplicemente a non intravedere queste energie/risorse, anzi, le disperde quasi totalmente affinché non si verifichino gli eventi di vita ambiti e tanto agognati. Eppure, grazie ad un lavoro introspettivo, e alla acquisizione di nuovi schemi adattivi, sarà possibile rinforzare lo stretto legame tra l’avere una positiva immagine di sé, ed affrontare le circostanze più o meno avverse con maggiore apertura ed accoglienza, senza il timore di un fallimento ripetuto senza sosta. Aumentare la propria efficacia percepita rende possibile una maggiora fiducia nell’altro oltre che in sé stessi. Ritenere di valere, a prescindere da ciò che accadrà, permetterà la creazione dell’immagine di una strada verso il proprio domani un po’ più spianata, con un Sé come protagonista del romanzo a lieto fine della propria vita. Parola di Counselor! E tu come affronti la vita, da ottimista, pessimista o da positivo realista? Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: analogie e differenze tra Counselor e Coach
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 03 June 2017
Molti messaggi mi sono pervenuti da ogni parte d’Italia in merito alla confusione tra quelle che sono le figure professionali tra il Counselor ed un Coach. Mi chiedete se vi è sovrapposizione professionale o di metodo, se sono figure professionali che tendono o meno alla collaborazione e molto altro ancora. Cercherò quindi, in questa sede, di dare una mera griglia informativa in merito a tale argomento. Partiamo con quelle che sono le loro analogie: sono entrambi metodi di sostegno e sviluppo alla persona che affondano il loro operato sulle risorse interiori della persona, in un’ottica di recupero e potenziamento delle competenze individuali. In entrambi i casi i clienti sono i protagonisti primari di ogni incontro. Counselor e Coach si avvalgono di una comunicazione empatica che miri a realizzare un contesto sicuro e degno di fiducia per il cliente. Entrambi i professionisti sostengono lo sviluppo di competenze trasversali utili alla persona nel corso della propria vita personale e professionale. Una ennesima analogia tra le due figure professionali sta nel fatto che sono legati ad un “contratto” nel quale vengono definiti gli obiettivi che il cliente desidererebbe raggiungere, obiettivi che vengono “monitorati” lungo tutto il percorso, della durata relativamente breve, solitamente trattasi di una decina di sedute per un percorso individuale, variabili in base agli obiettivi che ci si prefigge di voler raggiungere. Detto ciò, proviamo ad individuare quelle che invece sono le differenze tra le due professioni. Un cliente che sta attraversando un momento di empasse che mette a dura prova il suo modo di scegliere, di sentire e di percepire o che sente di provare un disagio emotivo o relazionale verso se stesso o l’esterno è decisamente attività del Counselor. Non solo, anche situazioni di attraversamento di una cosiddetta “fase di passaggio” quali una separazione, un lutto famigliare e per questo intendo anche del proprio animale domestico, la nascita di un figlio, l’avanzamento di una carriera anche se da tempo sognato ma pur sempre fonte di stress, il pensionamento e tutto ciò che richiede il bisogno di una maggiore autorealizzazione è ancora una volta un lavoro prettamente da Counselor. Fondamentalmente , il Counselor si occupa delle relazioni di aiuto con lo scopo di sostenere le persone nell’individuare nuove possibilità con la peculiarità di saper utilizzare quella famosa “arte di aiutarsi”, facendo sì che le persone possano scoprire le proprie rappresentazioni del mondo, comprenderne la natura e le origini, spronandole, laddove ve ne fosse necessità, a modificarle, mettendo le persone in grado di trovare risposte nuove e diverse alle problematiche che le stavano ostacolando. Il coaching invece aiuta gli individui a sviluppare competenze, liberare potenzialità soprattutto legate alla sfera professionale quale la capacità comunicativa, il lavoro in gruppo, la capacità di leadership. Tutti fattori cruciali per il raggiungimento di una performance professionale eccellente. Una mera focalizzazione, da parte del Coach, su quelle che sono le azioni, gli obiettivi, il rendimento, i risultati, le strategie e le soluzioni. Un approccio, quello del coaching, indicato alle persone che hanno già ottenuto validi risultati ma che desiderano alzare il loro livello di professionalità facendo nuove esperienze, realizzando nuovi traguardi gestendo con maggiore equilibrio la pressione professionale. Indubbiamente differenze sostanziali ve ne sono anche nell'utilizzo di metodologie adoperate sia per aumentare la capacità autoesplorativa del cliente, sia per “consegnargli” nuovi preziosi strumenti di consapevolezza personale. A questo punto non resta altro che interpretare la necessità effettiva delle persone/clienti ed indirizzarle verso il professionista giusto. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: quando si perde la determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 10 June 2017
Mi scrive Eloisa, 45 anni, di Fidenza: “Dottoressa cara, sapesse quante volte ho deciso di smettere di fumare, di iniziare una dieta dimagrante e non parliamo dei troppi abbonamenti palestra/piscina acquistati in pacchetti “all inclusive” e poi mai terminati. Questa cosa, oltre a farmi perdere dei soldi inutilmente mi demoralizza molto. Sarò io che non sono capace di arrivare fino in fondo alle cose? Mi sento come se mi mancasse l’energia. La motivazione iniziale poi si trasforma in pigrizia estrema. Le pare una cosa sensata?”. Gandhi asseriva che: “la forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomita”, questa volontà la possiamo identificare con un termine di uso quotidiano a noi tutti abbastanza noto, la MOTIVAZIONE, indispensabile per portare a termine i nostri obiettivi. Questa, è una sorta di forza motrice interiore che ci permette di superare gli ostacoli, ad ottenere successi nei vari campi in cui interagiamo, dai più quotidiani quali quelli lavorativi, relazionali a quelli ideologici come la realizzazione di sogni e ideali. Una volta che abbiamo ben chiari in testa i nostri scopi, la motivazione ci verrà in soccorso per mantenere l’equilibrio e portare avanti azioni ed energie necessarie per raggiungerli. La motivazione va allenata, rinnovata, stimolata e lo si può imparare giorno dopo giorno. Ma in quale maniera? Innanzitutto ricordiamo a noi stessi il senso della positività: elemento che ci obbliga, anche nei momenti di scoramento, di fasi della serie: “capitano tutte a me!, cos’altro mi dovrà ancora accadere!?” a individuare il lato positivo delle cose, a superare noi stessi, a progredire anche con tanto sacrifico. Lamentarsi meno e focalizzarsi sulle cose che ci piacciono, anziché divenire ridondanti verso quello che aborriamo è di certo un buon punto di partenza. Ricordiamo sempre che la nostra mente non fa distinzione alcuna tra le esperienze e ciò che noi ad essa candidamente raccontiamo. La mente, fortuna nostra, può essere condizionata positivamente dai nostri pensieri idealistici e positivi. Ovviamente, oltre al pensare positivo non dobbiamo dimenticarci dell’impegno, ci vuole dedizione e costanza nel fare le cose. Prefigurarsi delle scadenze, dei piani di azione e di riserva nel caso il macro obiettivo non fosse raggiungibile a breve termine. Impegnarsi nel pianificare degli obiettivi intermedi potrebbe essere davvero una buona strategia. Prendere sul serio se stessi e ciò che vogliamo è davvero una bella presa di coscienza e responsabilità motivazionale. Imparare a migliorare se stessi, accettando serenamente anche momenti di sfiducia e stanchezza, è un altro aspetto predominante al fine di tenere attiva la nostra motivazione. Non dobbiamo essere troppo “criticoni” e severi con noi stessi, rischieremmo di sentirci dei meri falliti ogni tre per due. Ricordarci di avere dei punti deboli, ammetterli, per poterci lavorare sopra in maniera consapevole, anziché demonizzarli è decisamente un’ottima scelta. Provare con il redigere una sorta di diario degli up and down. Appuntare gli avanzamenti piuttosto che i regressi, potrebbe rivelarsi un utile strumento per analizzare oggettivamente la situazione e pensare ad eventuali soluzioni possibili. Inizialmente potrebbe essere faticoso, soprattutto per chi di noi non è più avvezzo allo scrivere, ma con costanza non sarà di certo un ostacolo insormontabile da superare. Parola di Counselor! Grazie al diario potrebbe risultare più semplice visualizzare se stessi, come ci si vede, come ci si sente. Stimolare costantemente la mente con la curiosità, accendere le proprie antenne sensoriali per trovare ispirazione in qualsiasi luogo, elemento, avvenimento, persona, approfittando di ogni novità, portatrice di nuove idee e prospettive differenti, utili spesso alla risoluzione di problemi e al superamento degli ostacoli. In ultima istanza, ricordiamoci che fondamentale è il riconoscimento per noi stessi da noi stessi. Premiamoci, complimentiamoci con noi stessi, impariamo ad essere orgogliosi di noi, è fondamentale. Concediamoci del riposo meritato, un piccolo premio per gli sforzi messi in atto. Non aspettiamoci la pacca sulla spalla dagli altri, impariamo a guardarci nello specchio e a ringraziare noi stessi e ricordarci che siamo proprio in gamba! Imparare ad essere il primo tifosi di se stessi è davvero prezioso. E tu, quanto ti senti motivato? Tendi a scoraggiarti di frequente per poca fiducia in te? Avresti voglia di aumentare l’immagine positiva di te per migliorare le tue performances? Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: gli ambiti di applicazione del Counselor
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 26 May 2017
In molti mi avete chiesto, nei giorni scorsi, di raccogliere maggiori informazioni in merito alle molteplici applicazioni del Counselor nei differenti ambiti, da quello personale, relazionale, educativo e socio-sanitario, ma non solo. Decisamente la richiesta di una marcata affermazione di quella che è la professionalità del Counselor, denota un certo interesse e anche, credo, una consapevolezza nel volere scegliere eventualmente un professionista al quale affidare, una parte del proprio percorso di crescita personale, dettato da le più svariate motivazioni. Il counseling, la cosiddetta arte dell’ascolto empatico, ha lo scopo non solo di sostenere le persone in difficoltà a causa di piccole crisi momentanee di coppia, lavorative, difficoltà nella presa decisionale di un nuovo assetto familiare, lavorativo e molto altro ancora, ma ha una mission ancor più profonda, portare una ventata di calore umano e tanta fiducia nelle potenzialità auto-realizzative ed auto-guaritrici di ogni essere umano. Personalmente, in quanto Counselor sono fermamente convinta, che la chiave per aprire ogni sorta di serratura è già presente nella cassettina degli attrezzi di ogni individuo, io sarò presente, in veste di Counselor, supportando il mio cliente nel rovistare tra soffitte e cantine al ritrovamento della chiave, magari passandogli un nuovo panno per spolverare, un sacchetto vuoto nel quale depositare la spazzatura, sarò lì, con lui o lei, anche se la ricerca effettiva spetterà solo ed esclusivamente al mio cliente. Sarà lui o lei a comprendere quale scelta sarà o meno la migliore per sentirsi meglio e consapevole del proprio percorso da intraprendere. Ottica, questa, utilizzata in ogni ambito del counseling esistente. Tornando alla mappa in continuo aggiornamento, nei differenti ambiti di applicazione, mi pare opportuno differenziare l’operato del Counselor in: ambito individuale, all’interno del quale il Counselor opera come relazione di aiuto rispetto ad una o più situazioni di disagio, di tipo esistenziale o relazionale, momenti nei quali le persone hanno spesso bisogno prima di tutto di un orecchio attento e rispettoso per potersi esprimere liberamente, senza il timore di un giudizio esterno. Sentirsi accolte, ascoltate e comprese, spesso fa si che esse ritrovino da sole le energie necessarie per proseguire nel loro cammino. Vi è una parte di counseling rivolto al benessere e all’evoluzione personale dovuta ad un momento di crisi, un cambiamento improvviso, un’esitazione davanti a una scelta importante, tutte situazioni che potrebbero diventare occasione per riprendere in mano le fila delle propria esistenza e fare il punto della situazione nel rispetto dei propri valori, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. Una parte del counseling individuale riguarda anche il lato spirituale delle persone, dove per spirituale non si intende esclusivamente un legame con una religione, un credo, ma un desiderio di esplorare oltre i modelli imposti dalla società, verso una ricerca di connessione con un Tutto che ci circonda, avere la necessità di una visone olotropica, a 360 gradi rispetto il mondo esterno della natura e dell’universo. Sentirsi in connessione tra il dentro ed il fuori da se. Ma sostenere l’individuo singolo, senza pre-occuparsi della comunità, di certo non è “roba da Counselor”. Pensiamo nello specifico al counseling educazionale in ambienti scolastici e formativi, nei quali ambienti, i campi d’applicazione sono rivolti alla comunicazione, al saper gestire, oltre alla materia, anche dinamiche di gruppo, rapporti interpersonali conflittuali e diverse fasce di utenza: allievi o bambini, committenti o genitori, colleghi e superiori. Senza dimenticare di tutti quei percorsi di crescita adolescenziale in ambito sessuale, ambito in cui, la presenza di un counselor, con opportuna preparazione, può essere una figura chiave nell’accompagnare a vivere consapevolmente e responsabilmente la propria sessualità. Nessuna comunità è sguarnita di coppie e famiglie ed ecco che anche in questa area il counseling favorisce il miglioramento della qualità della relazione, grazie all’allenamento all’ascolto reciproco e all’empatia, individuando spesso il focus su un progetto comune. All’interno delle comunità (di accoglienza, di recupero, carcerarie, orfanotrofi…) l’importanza di avere la presenza di un facilitatore della comunicazione è una questione quasi del tutto evidente, tanto quanto potersi avvalere di Counselor esperti in materia interculturale. Nella attuale società multiculturale è necessario innalzare il livello di attenzione nei confronti dell’interculturalità per il bene della comunità accogliente e migrante. Lo stesso vale per il counseling delle emergenze, atto ad accogliere, contenere e incanalare le forti reazioni emotive delle persone coinvolte in catastrofi di ogni genere, dai terremoti agli attentati terroristici. Restano ancora due macro ambiti da sviscerare, quello lavorativo e quello socio-sanitario. In ambito lavorativo si parla di counseling aziendale che può operare in situazioni problematiche di tipo aziendale, considerando non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello umano, prendendo in considerazione fattori personali, emotivi e comunicativi di solito ignorati, eppure determinanti per un buon funzionamento aziendale. Supportare la persona nella sua globalità che viene sostenuta nel rafforzare il concetto di sé attraverso una corretta scelta di carriera, attraverso il cosiddetto “bilancio delle competenze” o career counseling è decisamente un altro aspetto metodologico del lavoro di un Counselor. Lo stesso vale per la gestione dei conflitti in ambito giuridico, molte dispute possono trovare accoglienza e spesso, risoluzione, se affrontate con un Counselor esperto nella gestione dei conflitti ancor prima di arrivare davanti al banco di un Giudice. Non mi resta che esplorare assieme a voi la sfera socio-sanitaria nella quale un Counselor può scegliere di operare in ambienti ospedalieri, con lo scopo di rinforzare la comunicazione tra medici e pazienti, ritornando così ad una visione più olistica del paziente e non solo a livello diagnostico. Il benessere di persone ospedalizzate può passare anche attraverso all’utilizzo della arte terapia: musica, teatro, poesia, danza, scrittura, scultura e altre forme di attività creative possono essere abbinate a un percorso in funzione del benessere dell’individuo. In ultimo, quasi a concludere anche il naturale ciclo vitale, la presenza del Counselor in situazioni di accompagnamento alla morte di sé o dei propri cari umani e animali, è fondamentale in una società in cui la morte è un tabù, qualcosa di astratto e lontano che riguarda sempre gli altri. Non se ne parla, non ci si pensa, ma quando tocca da vicino, ci obbliga ad un lavoro molto profondo da fare per affrontarlo il più possibile serenamente. Quindi, nulla di cui temere o di cui vergognarsi se in un periodo della propria vita si ha la sensazione di non farcela del tutto da soli e quindi trovare uno spazio ed un tempo da dedicare a se stessi, in una relazione di sostegno assieme al proprio Counselor di fiducia di certo non denota nessun fallimento, anzi, può solo che portare un ulteriore arricchimento nella conoscenza di se. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: problemi quotidiani di comunicazione nella coppia, alcuni suggerimenti
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 12 May 2017
Spesso mi capita di vedere delle coppie che si rimpallano reciprocamente colpe, accuse, aspettative deluse. Soffermandomi con loro a valutare singolarmente, una ad una, le problematiche che ritengono dover sviscerare in maniera più approfondita, le tipiche frasi che esprimono sono un fac simile delle seguenti: “Quando lei è nervosa non fa che piangere. Se ci sediamo a parlare diventa scontrosa o addirittura si trincera nel silenzio. Sembra tutto inutile. Mi viene voglia di arrendermi. Quando cerco di spiegargli perché sono nervosa, perché sto piangendo, lui mi interrompe dicendomi che non sono cose poi così gravi, e che dovrei passarci sopra. Questo mi dà ancora più fastidio, mi fa sentire non compresa, una stupida”. Alla base di queste espressioni c’è il desiderio reciproco di essere capiti, di voler comunicare all’altro, spesso senza riuscirci, il proprio stato d’animo, la propria sofferenza. Le persone, è ormai risaputo, comunicano in maniere differente in base all’educazione ricevuta, al contesto sociale e culturale nel quale sono cresciuti ed anche per dei schemi acquisiti in passato. Non voglio assolutamente asserire che vi siano delle maniere più o meno esaustive ed esemplari per comunicare, ma di certo posso provare a rendervi partecipi del fatto che alcune strategie, incentrate su teorie consolidate da tempo ormai, possono risultare più proficue di altre. Decisamente va reso merito ai 5 assiomi della comunicazione di Watzlawick, i quali si focalizzano su dei principi cardini: l’impossibilità di non-comunicare (poiché si comunica non solo con le parole, ma con tutto il corpo, anche scegliere di tacere quindi, è un modo di comunicare qualcosa di noi agli altri); la comunicazione si basa su due livelli, quello del contenuto del messaggio comunicato in se e il tipo di relazione che si presenta tra gli interlocutori; terzo assioma: la punteggiatura presente all’interno della comunicazione fa la differenza in maniera inequivocabile (si può dire la stessa frase con accezioni ben differenti in base alla punteggiatura, tono di voce, il “non detto tra le righe”. Es.: Apri la Porta! Apri la porta?); la comunicazione avviene sia in maniera analogica che digitale, vale a dire rispettivamente in maniera non verbale (aggiungiamo immagini, segni, simboli) e verbale; quinto ed ultimo assioma della comunicazione asserisce che le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i soggetti che comunicano sono sullo stesso piano (due amici), e di tipo complementare, in cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (la mamma con il figlio). Ovviamente è possibile, spesso a fatica, imparare a comunicare meglio, non sottovalutando il fatto che mettersi in discussione in prima persona, nel caso in cui l’altro non ci comprende, potrebbe essere un buon punto di partenza. Chiediamoci: sono certa che mi sia espressa in maniera comprensibile? Ho divagato tra i miei pensieri ad alta voce oppure ho davvero espresso in maniera semplice e concisa il mie pensiero? Ho provato ad empatizzare col mio interlocutore esprimendomi con un linguaggio comprensibile? Piccoli spunti di riflessione per una presa di consapevolezza e responsabilità. Dopo tanto tecnicismo, non va perso di vista il fatto che alla base di tutto, evidentemente, vi è il rispetto per l’altro, per l’interlocutore, per il vostro partner. La mancanza di rispetto crea evidente tensione, fomentando ulteriormente le incomprensioni. Non dimentichiamo, inoltre, che a molti piace più parlare che ascoltare e tal atri sono restii ad esprimere i propri sentimenti, anche al proprio partner. Alcuni suggerimenti utili potrebbero essere quelli di: ricordarsi di resistere all’irrefrenabile impulso di irrompere mentre l’altro sta parlando, imparando ad ascoltare pazientemente fino in fondo e solo allora eventualmente provare a rispondere o dire il proprio pensiero. Molto spesso sarebbe davvero saggio lasciar “decantare” la rabbia e la frustrazione del momento, prendendosi uno spazio ed un tempo propri dove ritrovare la propria centratura nel qui ed ora. Predisporsi al confronto, in maniera più rilassata e gentile, con il mero intento di comprendere, anche se non condividere eventualmente, il punto di vista dell’altro. Avere la consapevolezza che l’altro possa avere punti di vista, esigenze divergenti dalle nostre è un grande merito, soprattutto perché consequenzialmente sta ad indicare una accettazione soggettiva delle proprie esigenze senza farsi sopraffare dagli altri. Essere in coppia non significa essere l’uno la copia esatta dell’altra, in coppia va rispettata la individuale soggettività ancor prima del noi. Mettersi nei panni dell’altro è decisamente un punto a vantaggio della comunicazione efficace. In merito a questo: gli occhi funzionano in maniera distinta rispetto alle orecchie, ma è grazie alla loro cooperazione che riusciamo ad attraversare la strada sani e salvi. Assolutamente da evitare, cosa molto gettonata nelle serie tv, parlare male del proprio partner agli amici o ai parenti. Rischiate di mettere in cattiva luce non solo il partner ma anche voi stessi e la vostra coppia e decisamente gli altri non dovrebbero sentirsi parte giudicante. Le triangolazioni non sono mai state di ausilio in nessuna situazione, nessuna eccezione in caso di disguidi amorosi. Inoltre, a volte non dire nulla e restare in silenzio non sarebbe affatto una cattiva idea. Qualche piccolo esercizio da fare col proprio partner: elenca alcune ragioni per cui il modo di vedere o fare le cose del tuo partner sono migliori del tuo; chiediti come le divergenze di opinione del tuo partner abbiano arricchito la vostra coppia; chiediti perché sarebbe meglio fare come suggerisce il tuo partner; soprattutto ricorda a te stesso e all’altro gli aspetti più lieti della vostra coppia, potreste reciprocamente affermare: la cosa migliore del nostro rapporto è….; nella nostra coppia, quando stiamo assieme mi sento felice quando….; mi sento amato/amata da te quando…..; quello che più amo di me è…; quello che più amo di te è… Potreste continuare così per molti quarti d’ora. Rincarare la dose solo su aspetti critici e negativi del rapporto certamente non vi aiuterà né a risolverli e tantomeno vi consoliderà maggiormente. Non dimenticate mai di ricordarvi spesso, anche delle gioie ed dei punti di forza che rendono unica la vostra coppia. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: amori online, scappatoie o nuove realtà?
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 06 May 2017
Raffaella, 36 anni, single da troppo tempo ormai e: “loro sono tutti uguali”. È così facile scegliere qualcuno con cui passare una serata romantica o semplicemente trascorrere giorni e giorni a scriversi nelle chat, occhio non vede, cuore non cede. Oggigiorno è sempre più frequente incontrare le persone online, grazie agli innumerevoli siti d’incontro. Secondo una classifica italiana, i migliori e più gettonati siti d’incontro online sono davvero molti, eccovene alcuni con dati alla mano: be2 (3milioni di singles dai 40 ai 70 anni), meetic (400mila singles dai 30 ai 70 anni), Soloavventure (120mila singles o presunti tale dai 20 anni circa)…potrebbe continuare ancora per qualche riga la lista, ma mi fermo qui. Giudicanti o meno, l’era digitale, dell’amore liquido di Bauman ha rivalutato non solo gli affari e lo shopping ma anche le relazioni sociali. Per come commenta Justin Garcia, il direttore all’Istituto Kinsey per le ricerche sul sesso: “la storia dei rapporti amorosi ha avuto due evoluzioni: la prima 10mila anni fa, quando, con l’agricoltura, da nomadi siamo diventati stanziali. La seconda, con l’avvento del Web: per anni ci siamo conosciuti alle feste, a scuola o al lavoro. Ora lo facciamo su Internet.” Le persone hanno sempre meno tempo da dedicare agli incontri di “scoperta” e conoscenza dell’altro, quindi preferiscono conoscere molti partner ideali, analizzando profili con un click. Profili che mettono in bella mostra l’aspetto fisico: occhi, capelli, labbra seducenti, immagini vedo non vedo e parole chiave per carpire ciò che piace e ciò che si aborra. Vi sono ricerche in merito a quali sono i profili più gettonati, profili che pare ricalchino dei meri cliché: profilo breve, chiaro, originale, senza dimenticare lo humor; immagini in cui si viene ritratti con un sorriso sincero e la testa leggermente inclinata ad esprimere disponibilità e dolcezza, ricordando di inserire non solo primi piani ma anche immagini a figura intera; usare la parola “amore” nella descrizione di se e di cosa si sta cercando, sembra avere un successo maggioritario rispetto ad altre e così via discorrendo. Il punto è che spesso nei profili mente la stramaggioranza degli iscritti, si mente sul peso, l’età, sull’essere o meno single, avere o meno figli e anche sul cercare una relazione duratura, quando alla stregua, pare si stia vagliando la possibilità di una “botta e via” facile e non troppo impegnativa nella fase del corteggiamento. Gli algoritmi che mettono in contatto le persone tra di loro potrebbero basarsi sulla similarità o sulla complementarità, il fatto sta che non è ben chiaro se il livello di istruzione viaggia di pari passo alla simpatia e soprattutto dove la mettiamo l’alchimia di odori e sapori? Magari ci si incontra per interessi comuni ma poi la scintilla alchemica non scatta. Eppure, nonostante le innumerevoli critiche a questi nuovi metodi di incontri relazionali, spezzare a loro favore una lancia pare doveroso: questi siti, mettono in contatto un gran numero di persone, allargando così la cerchia di conoscenze soprattutto per quelle persone che hanno minor possibilità, basti pensare ai genitori divorziati, lavoratori impegnatissimi, gay, persone arrivate da poco in una nuova città o semplicemente soggetti molto timidi che possono tentare di riprendere un minimo di fiducia nell’approcciarsi ad un ipotetico presunto partner. Senza escludere il fatto che sono molte le testimonianze di incontri seri avvenuti online e confermatisi poi nella vita reale sia a livello relazionale di coppia che amicale. Il rovescio della medaglia sta nel fatto che tra questi utenti si possono trovare un certo numero di malintenzionati, violenti, stalker e tanto altro. Regolamentare l’accesso alle persone a tali siti di certo non è facile. Resta il fatto che l’amore è una questione delicata da trattare dalla A alla Z, passando per ogni singola lettera dell’alfabeto che vi è in mezzo, ma come nella vita reale, giocarsi la carta della lealtà e del rispetto offrirà maggiori chance nell’attirare persone simili a se, senza restare troppo delusi da risposte negative al proprio profilo e alla richiesta di incontro o nella peggiore delle ipotesi nel riceverei una fittizia risposta in stile “incontriamoci” e poi tabula rasa, l’altro sparisce dalla videata e sarà impossibile rintracciarlo. Inoltre, va rendicontato il fatto che una relazione d’amore online, può essere molto seducente, soprattutto perché lascia ampi margini all’immaginazione e fomenta le aspettative e i bisogni personali senza che ci si renda del tutto conto della cosa. Quindi, il consiglio sta nel non proseguire troppo nel fascino dell’ignoto e incontrare l’altro il prima possibile, magari in un bel luogo pubblico e prendendo le stesse accortezze che da sempre, son state adottate da chi ha incontrato amori più o meno duraturi nella vita, alle feste del paese qualche lustro fa. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: educare una società intera contro la violenza di genere
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 25 November 2017
Oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne. Giornata di sensibilizzazione a 365 gradi, tanti quanti sono i giorni nell’anno. Un problema sociale e culturale che necessita di un importante percorso in merito alla ricostruzione di un modo nuovo di relazionare tra donna e uomo, un cammino ri-educativo sulle nuove generazioni. Mai cosa più difficoltosa vi è stata come quella di scardinare, sradicare stereotipie di genere ma non solo, alla base di violenze giustificate e prive di alcun fondamento umano e sociale. In particolare, lo stereotipo di genere, basandosi sulle false credenze rispetto agli attributi personali delle donne, implica inevitabilmente specifiche aspettative culturali rispetto ad: apparenza, occupazione, competenze, abilità, interessi, come se si trattasse di una lente deformante, che distorce e reinterpreta la realtà sulla base delle credenze e delle aspettative, infondate, sulle quali si basa. Purtroppo, vi è ancora oggi un gran numero di persone che subisce i condizionamenti dettati dagli stereotipi, associando determinate attività piuttosto che determinati comportamenti o atteggiamenti all’uomo piuttosto che alla donna (in questo caso specifico di stereotipia di genere, la cosa vale anche per stereotipie legate ad etnie, estrazione sociale, credo religioso e tanto altro ancora). Il consolidarsi e il persistere degli stereotipi, ha fatto sì che essi venissero riconosciuti come caratteristiche biologiche specifiche dei due generi, in quanto, essendo “reiterati nel tempo, gli stereotipi portano a ritenere “normale” ciò che suggeriscono” (Priulla, 2011). Ma allora che cosa possiamo fare per debellare queste assurde stereotipie offensive, distruttive se non addirittura in taluni casi mortali? L’unica strada possibile consiste nel cambiare l’atteggiamento mentale delle persone, iniziando a educare i bambini e i ragazzi, ovvero le donne e gli uomini di un domani, nella direzione della valorizzazione delle differenze di genere e non nel loro screditamento. In molti ormai sanno, che essi siano genitori o meno, quanto sia difficile educare i figli, ancor più educarli alla parità e alla valorizzazione di genere. Tuttavia è nostra responsabilità orientarci in questa direzione, se vogliamo dare e trasmettere alle nuove generazioni un futuro diverso e migliore. Ma in concreto, in cosa consisterebbe educare alla parità di genere le nuove generazioni? Innanzitutto equivale a trasmettere il seme del rispetto e della valorizzazione delle differenze, comunicando ai bambini il concetto che maschi e femmine sono diversi fisicamente, hanno un diverso modo di comportarsi, relazionarsi e comunicare ma questo non significa che uno è superiore all’altro, bensì che devono avere gli stessi diritti, meriti, opportunità e riconoscimenti. Evidentemente i nostri ragazzi devono poter ritrovare conferma e coerenza tra quello che gli adulti asseriscono e il comportamento che questi ultimi mettono in atto a scuola, in famiglia, per strada. Molto importante sarebbe insegnare ai nostri giovani che il riconoscimento e la valorizzazione avviene per come gli esseri umani sono e per le peculiarità, capacità e abilità soggettive che essi hanno, a prescindere dal genere di appartenenza e/o allo status sociale; questo favorirebbe lo sviluppo di un pensiero critico nei bambini anche nei confronti dei messaggi pubblicitari o dei racconti che tuttora si trovano in alcuni libri di scuola. Sono fermamente convinta che solamente tramite l’educazione delle nuove generazioni all’insegna della valorizzazione delle differenze e della parità di genere (e non solo di genere), si possa, passo dopo passo, arrivare finalmente alla costruzione di un nuovo pensiero collettivo sempre più incline alla soppressione di stereotipie arcaiche e infondate. In ultimo, sarebbe molto importante accrescere il senso di autostima, di resilienza nelle donne mature di questa era, intraprendendo con esse dei percorsi di vero abbandono di secoli di sensi di colpa, dettati dal dover fare e dover essere senza poter recriminare spazi personali e senza potersi spesso permettere di urlare un NO verso l’esterno, con il semplice diritto di far prevalere le proprie priorità, i propri bisogni e desideri. Sostenere gli uomini maturi di questo periodo storico ad ammettere fragilità e senso di smarrimento del tutto umani e non come maschere da celare sotto corazze d’amianto luccicanti. Insegnare un nuovo modo di contattare le proprie paure senza sentirsi perdenti o scherniti da secoli di stereotipie infondate. Un processo lento e faticoso che una volta innescato, sarà inarrestabile. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il Counselor chi è? Di chi e di cosa si occupa?
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 22 April 2017
Prova ad immaginare due cerchi che si intersecano tra loro, in un cerchio, mentalmente, individua tutte le professioni legate alla salute mentale: psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista. Nell’altro cerchio, individua sempre mentalmente, la figura professionale del Counselor, maggiormente legata al benessere individuale e sociale; nello spazio di intersezione tra i due cerchi, troverai una sorta di parziale sovrapposizione tra tutte queste figure, poiché tutte hanno a che fare con la relazione di aiuto. Mentre nel cerchietto della salute mentale parleremo di professionisti e utenti o pazienti, nel cerchietto del counseling parleremo di Counselor e dei suoi clienti che essi siano singoli, coppie, gruppi, aziende. Questa precisazione nell’uso corretto del gergo da adottare è doveroso nel rispetto di ogni singola professione e nella possibilità di una collaborazione proficua tra esse, col fine di creare una rete di prevenzione e sostegno per chi ne abbia necessità. Il Counselor non necessariamente deve essere anche dottore in psicologia, anche se spesso così è come nel caso specifico della sottoscritta. Torniamo a te che stai leggendo e che hai finalmente la sensazione netta di chiarirti le idee su quella che è la mia figura professionale: in quanto Counselor offro il mio tempo, la mia attenzione in maniera professionale, interessata, empatica, partecipativa, il mio rispetto, la mia presenza senza giudizio alcuno rispetto a chi potrebbe ritrovarsi nella vita, in una condizione di difficoltà, di incertezza, di fragilità, dubbio, rispetto ad un momento di presa decisionale a causa di una relazione in crisi, di una situazione difficoltosa a livello lavorativo, familiare, coi figli, nel settore scolastico o semplicemente per il desiderio di affrontare un percorso di autoconsapevolezza e crescita personale, col fine, di ritrovare le proprie risorse interne, il proprio equilibrio, sfatare e smontare la “voce grossa” perennemente presente del proprio giudice interiore. Fermamente convita, come insegna Carl Rogers (uno tra i padri fondatori del counseling) che in ogni essere umano vi sono insite, le risorse necessarie per superare ogni difficoltà, basta favorirne l’autostima, la fiducia personale e la responsabilità nella presa delle proprie decisioni, con una comprensione empatica ed attenta da parte del Counselor. Prova ad analizzare assieme a me il sostantivo counseling, derivante dall’inglese to counsel che a sua volta, a ritroso, si rifà al latino consulo-ĕre, traducibile in consolare, confortare, venire in aiuto. Quest’ultimo si compone della particella cum (con, insieme) e solĕre (alzare, sollevare), quindi arriviamo al significato di Counseling che è riconducibile a consolare, sollevare insieme o anche stare con la persona sola. Siccome per porre fiducia in un professionista necessitiamo non solo di astrazione ma anche di dati più concreti, tangibili, ecco alcune basi normative oggettive: il Counselor può intervenire in vari ambiti: privato, sociale, scolastico, salute, aziendale. Il Counseling è una professione intellettuale svolta ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Per esercitare la professione di Counselor è richiesto un diploma triennale rilasciato da Scuole di Formazione in Counseling accreditati da un’Associazione di Categoria, spesso il Counselor è anche laureato in psicologia, anche se la legge ad oggi non lo richiede in quanto requisito indispensabile. Il Counselor è tenuto al rispetto del codice deontologico e del segreto professionale, all’aggiornamento professionale permanente e al rispetto di precise norme etiche. Le metodologie a disposizione di un Counselor, da affiancare all’ascolto attivo del cliente, variano in base all’approccio teorico di base, spaziano da tecniche maggiormente olistiche del respiro, della meditazione, dell’arte in ogni sua espressione creativa che avnno dal disegno, alla danza, alla scrittura. La professionalità del Counselor sta non solo nel saper padroneggiare tali tecniche ma scegliere tra quelle più consone al proprio essere Counselor. Ancora una piccola delucidazione sulla distinzione dell’operato, in linea generale tra Counselor e psicologo, psicoterapeuta-analista: 1. Il Counselor si occupa di situazioni che riguardano sì l’area del benessere dei suoi clienti, ma potenziandone i punti di forza senza che vi siano patologie conclamate che necessitino di un professionista altro da esso; 2. I tempi di durata della consulenza sono spesso più brevi nel caso di incontri di counseling e si focalizzano sul “qui ed ora”, sul presente del cliente senza andare a scavare nel passato più o meno remoto e senza andare a ricostruire personalità in difficoltà; 3. Il Counselor supporta, orienta, sviluppa autonomia decisionale tramite anche training di abilità specifiche, ma non riabilita, non cura, a differenza degli addetti alla psicologia; 4. Inoltre un Counselor, a meno che non sia anche uno psicologo, non può svolgere attività di somministrazione e valutazione di test cognitivi, attitudinali o di personalità. Il Counselor può operare da solo ma anche in rete, cosa che auspico vivamente, con gli altri professionisti della salute mentale, avvalendosi di equipe periodiche e supervisioni in merito ai singoli clienti. Sperando di aver fatto breccia nella tua mente con qualche piccolo tassello in più rispetto al puzzle del mondo del Counseling e avendoti fornito maggiori strumenti utili al fine di poter seguire piccole “pillole” di Counseling con Ciabattoni Letizia in questo spazio a te dedicato caro cliente, ma avendo anche il piacere di intraprendere un percorso personale di crescita in maniera del tutto rispettoso verso le tue inclinazioni più o meno nascoste ed in un ambiente accogliente e professionalmente protetto. Non mi resta che concludere con una citazione del grande Maestro Carl Rogers: “E’ una situazione in cui calore umano, accettazione incondizionata e assenza di ogni pressione personale da parte del Counselor permette l’espressione più libera di sentimenti, comportamenti e difficoltà da parte del Cliente”. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia. Scontri ormonali: menopausa versus adolescenza
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 25 November 2017
In questo periodo storico e sociale nel quale il gap generazionale tra genitori e figli si è molto allargato, ci si dimentica spessa di un dettaglio non da poco, e cioè che lo stravolgimento ormonale dei figli, spesso coincide anche con quello delle madri e dei padri. Secondo un’indagine del 2010, il 22% di tutte le persone con figli tra i 12 e i 17 anni ha più di cinquant’anni e il 46 % più di 45. Biologicamente parlando, questo significa che un elevato numero di mamme si trovano in una condizione di menopausa o pre-menopausa nel periodo in cui i loro figli e figlie si affacciano al magico mondo dell’adolescenza o della pre-adolescenza. Una mera bomba ad orologeria. Molte donne attraversano questa fase senza particolari problemi, proprio come i loro figli attraversano tranquillamente la pubertà, ma altre lottano tra malinconia e irritabilità, vedendo inconsciamente nella loro situazione lo specchio rovesciato dei loro figli, che stanno entrando, a differenza loro, negli anni più fertili. Ma andiamo a sottolineare che la cosiddetta età di mezzo e l’adolescenza hanno in comune il cambiamento, un doppio passaggio familiare che spesso va a impattare maggiormente sulle mamme che sui figli stessi, i quali vivono un senso di disorientamento passeggero e fisiologico, a differenza degli scompensi ormonali delle mamme over, le quali inoltre risultano il triplo coinvolte rispetto ai loro partner nel quotidiano dei loro figli. Mamme più stanche fisicamente, costrette a dover combattere tra orari di rientro serale e compiti di scuola da dover sollecitare dei propri figli ormai sulla soglia della giovane età adulta. In tutto questo un vero e proprio fortissimo divario generazionale nell’utilizzo della tecnologia, nel modo di comunicare e vestire. Ma la domanda che ci poniamo spesso è: per crescere è davvero necessario lo “scontro” generazionale? Uno scontro che avviene maggiormente tra mamme e figli o meglio tra mamme e figlie poiché la figura paterna è percepita dagli adolescenti meno conflittuale, meno “restrittiva”. Ovviamente ogni storia va da sé. Generalizzando, gli adolescenti “sentono” che la relazione materna offre maggiori difficoltà verso l’autonomia, dal momento che c’è una maggiore dipendenza affettiva, mentre il padre viene percepito come favorevole all’autonomia, al lasciar andare per esplorare il mondo. Ecco che il ruolo materno risulta spesso ambivalente poiché da un lato infonde sicurezza, calore, mentre d’altro canto rende indipendenti. In questa fase si instaura così un processo di idealizzazione caratterizzato da eccessi che spesso si alternano con fasi svalutative, sottoponendo la madre come un vero “bersaglio di queste aggressioni”, la quale spesso se ne lamenta e se ne rattrista, ancor più se già scompensata ormonalmente dalla sua fase “maturativa” di menopausa o pre-menopausa. Ma allora non vi è nessuna ricetta assoluta e perfetta per gestire al meglio tale fase familiare. Le grandi teste esperte in tale tematiche ci insegnano alcuni piccoli accorgimenti più o meno pratici tra i quali la metafora del “tiro alla fune” tra genitori e figli: "Il genitore potente che tende a tirare sempre la fune dalla sua parte, ci dice Pellai, esperto in età evolutiva, obbliga così il figlio a essere solo ubbidiente, non lo lascia mai giocare la sua partita e, quindi, neppure diventare grande. A un comportamento del genere il figlio reagisce spesso covando, piano piano, rabbia e ostilità. In più, tra divieti, regole e paletti, il ragazzo non riesce a fare esperienze (necessarie per crescere) e non si costruisce una adeguata muscolatura emotiva”. Ma se tirare sempre con forza la fune non va bene, altrettanto scorretto è l'atteggiamento del mollarla subito. In questo modo, il figlio tira e si trova allo sbando perché non c'è più nessuno dall'altra parte a giocare con lui. Vince, insomma, senza fatica. Ecco che il genitore dovrebbe essere disponibile a “giocare la partita” con il figlio, calibrando la forza con cui tira la fune. Molto importante è anche il fatto di non cedere a tutte le richieste dei figli, “costringendoli” invece a negoziare con il genitore le proprie richieste, il quale (genitore) dovrebbe assumere una funzione di contenimento, da filtro alle svariate richieste del figlio. In fine, ricordiamo che ogni problematica del figlio adolescente, richiede e merita la giusta attenzione, guai a svalutare quelli che per i ragazzi vengono percepiti come insormontabili problemi, si rischierebbe di far vacillare maggiormente la loro autostima, già così tanto minata di suo in questa delicata fase del ciclo della loro vita. Evitiamo, se possibile, di fare gli “amiconi”, i figli si aspettano un genitore in grado di porsi in maniera matura e accogliente che non screditi la loro voglia di autonomia e soprattutto evitiamo di fare dei continui paragoni con la nostra vita passata da adolescente appartenente a contesti stoici e sociali differenti da quello odierno. Nulla di semplice ovviamente ma neppure di totalmente impossibile e insormontabile. Inoltre non dimentichiamo mai che la possibilità di partecipare a gruppi di supporto, di crescita e di sostegno sia per i genitori che per i figli durante questa delicata fase di maturazione per entrambe le fazioni esistono e possono essere una valida base di appoggio e di confronto esperienziale. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: quando i rimproveri eccessivi e indiscriminati diventano dannosi
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 09 December 2017
Inizierei con dare una delimitazione letterale al termine criticismo, con il quale si intende un atteggiamento di rimprovero ripetitivo e pervasivo, in cui chi rimprovera mostra il proprio disappunto o disapprovazione a qualcuno, in modo che questi possa correggere il suo errore o ravvedersi. Tale condizione presuppone una valutazione negativa di un comportamento o atteggiamento, che viene ritenuto sbagliato. I motivi per cui le persone si sentono in diritto di rimproverare possono davvero essere i più svariati e guidati da scopi differenti. In maniera particolare, attraverso differenti ricerche sociali, si è potuto notare che il rimprovero viene agito principalmente con l’obiettivo di cambiare il comportamento altrui ritenuto scorretto e ottenere così una sorta di “risarcimento” dell'eventuale percezione, o meno, del danno subito. Ma non si limita a questo, difatti può essere anche un modo, del tutto scorretto e diseducativo, aggiungerei personalmente, per sfogare la propria rabbia più o meno repressa, la propria frustrazione o per porsi in una situazione di superiorità (di “Giudice Interiore”) mettendo l’altro in situazione di inferiorità o “debito” morale e mentale. Come ho già evidenziato nel titolo: il rimprovero è da considerarsi dannoso quando viene espresso in maniera ripetitiva e pervasiva. Alla base delle persone fortemente “criticone” sembra vi sia una mancata presa in considerazione dei bisogni e dei desideri altrui, dei punti di vista alternativi al proprio. Non dimentichiamoci però che molto spesso noi siamo i peggiori e più acerrimi rimproveratori di noi stessi, non sempre ci accontentiamo del rimprovero altrui nei nostri confronti, bensì siamo del tutto autonomamente in grado e anche in maniera egregia, di buttarci addosso valanghe di spergiuri e giudizi negativi. Ovviamente non si può evitare di evidenziare una forte mancanza di autostima e di esagerato senso di colpa, in scenari simili. Facciamoci qualche domanda in merito. Quanto, siamo noi stessi a permettere agli altri di emanare una sentenza negativa verso la nostra persona, il nostro operato? Quanto poco crediamo in noi stessi al punto da farci letteralmente schiacciare dal giudizio esterno? Necessitiamo di un parere estraneo a noi per sentirci gratificati o per sprofondare nella desolazione del sentore di nullità, di uno zero assoluto? Evidentemente siamo “aniamali sociali” e in quanto tali condividiamo molta parte del nostro tempo con gli altri e ci confrontiamo con essi, questo è del tutto normale e positivo ma nel momento in cui gli altri diventano una specie di dipendenza assoluta sul quale soppesare la nostra immagine, il nostro essere, allora forse dobbiamo rimetterci a lavorare sulla nostra capacità di sentirci migliori di ciò che crediamo e di sviluppare maggiori capacità di auto-efficacia percepita, autostima, assertività e anche magari nella scelta delle persone delle quali ci circondiamo. Tornando agli effetti della eccessiva critica: potrebbe sviluppare la tendenza al senso di colpa, del giudizio verso se stessi come un individuo cattivo e dannoso per se e gli altri. Potrebbe portare tristezza, debolezza, fragilità, ansia da prestazione e minare la propria sensibilità in maniera da frantumarla. Non solo, l’eccesso di critica può portare al “disorientamento personale”, vale a dire al non sapere quali siano in effetti le proprie preferenze, opinioni, capacità. O qualora lo si sappia, si potrebbe giungere al considerarle non idonee, insufficienti, sbagliate. Ecco che potrebbero derivare una mancanza di fiducia in sé stessi e una continua messa in discussione delle proprie scelte (Avrò sbagliato qualcosa anche questa volta? Ma avrò fatto bene?). Ancor peggio si potrebbe rischiare di andare alla continua ricerca dell’approvazione esterna. In ultimo, potremmo rischiare una eccessiva scarica di rabbia verso gli iper critici, reagendo in maniera oppositiva, ribelle, aggressiva, innescando così un circolo vizioso di malessere reciproco. Detto ciò, visto che non siamo addetti al mutamento degli altri bensì siamo responsabili del nostro maturare e accrescere la conoscenza di noi stessi, impariamo a soppesare non solo il giudizio altrui ma anche quello personale e proviamo ad essere onesti con noi stessi chiedendoci quanto potremmo lavorare sul rafforzare la nostra autostima. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: vittimismo e autocommiserazione potrebbero essere maschere
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 18 November 2017
Franca: “Mi creda, io non sona mai stata felice. Vedo gli altri felici per mille motivi eppure a me non capita mai di esserlo. Forse pretendo troppo? Forse ho un target troppo elevato di aspettative? Mi dica Lei dottoressa.” Non di rado sento affermazioni simili a quella di Franca che pare abbia la fervida idea che la felicità non dipenda da lei, con il rischio di sentirsi incapace e di rimanere in attesa di un qualcosa di “fatato” che non sarà mai per come lo aveva davvero sognato. E se dicessi a Franca e a tutti noi che la felicità è concretamente una competenza da imparare e da costruire pezzetto dopo pezzetto, partendo dallo sviluppare una forte componente emozionale? Quando parliamo della felicità non dobbiamo dimenticare che stiamo innanzitutto discorrendo di uno stato d’animo, uno stato umorale, appartenente più al mondo delle passioni che non a quello della logica razionale. Ecco perché per provare felicità ci vuole soprattutto una grande competenza emotiva, legata alla capacità di gustare le emozioni della vita. Evidentemente la felicità non si sposa di buon grado con i nostri atteggiamenti di autocommiserazione e vittimismo, con i quali, tra le altre cose, ci lamentiamo con noi stessi e con gli altri, rinforzando il problema e facendo attrito nei confronti di ciò che sta accadendo. Martha Medeiros scrisse: ”Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna”. Posso asserire che l’autocommiserazione è uno tra i peggiori nemici di noi stessi e spesso viene camuffata dalla maschera della vittima che gioca anche il ruolo di carnefice, assegnando a qualcun altro, senza assunzione alcuna di responsabilità, il ruolo di “salvatore” ma di fatto, strumentalizzandolo per raggiungere i propri scopi. Il “gioco” che molto spesso si innesca è che quando l’altro si ribella o tenta di abbandonare la partita (e prima o poi capita), la vittima lo accusa di essere il carnefice facendolo sentire in colpa per aver rinunciato al ruolo di salvificatore, alimentando così ancora di più il proprio copione vittimistico. Un vero duello all’ultimo sangue. Vittimizzare, spesso e volentieri equivale a vivere la propria vita in maniera passiva. Proiettando fuori ciò che non funziona, rifiutiamo ogni attribuzione di responsabilità della situazione che si è venuta a creare o piuttosto abbiamo la mancanza di volontà di metterci in discussione e riconoscere i nostri errori. L’incapacità di guardare dentro di noi ciò che non funziona, insieme al grande investimento di energia nell’atteggiamento negativo, non determina solo lo status quo della situazione presente ma produce un rafforzamento del problema. Ecco che pensiamo e ci rapportiamo agli altri con un atteggiamento “pesante”, carico di risentimento e negatività impedendo così la risoluzione della situazione esterna e anche l’evoluzione e la maturazione della nostra persona. Per intenderci: lamentarsi sporadicamente per una giornata faticosa, un incidente di percorso non calcolato e simili, offre molto spesso una momentanea valvola di sfogo ad un vissuto negativo che genera disagio e malessere. Donna vittimismo cronicoIl problema si presenta nel momento in cui, lagnarsi, diventa una modalità costante e una reazione abituale alle circostanze esterne, rischiando, oltremodo, di innescare nella nostra mente una serie di pensieri negativi capaci di intrappolarla in un circolo vizioso che si autoalimenta, svuotandola di energie e bloccando le nostre risorse personali (ricorda che la mente mente). La vita ci propone quotidianamente delle sfide, più o meno grandi che difficilmente scegliamo e che spesso non possiamo evitare, possiamo però tentare di smettere di resistere a ciò che ci sta accadendo, accettando i nostri limiti e promuovendo le risorse che ci consentono di tollerare ciò che non è nel nostro potenziale poter mutare. Poi vi sono le cose che invece possiamo affrontare con una attitudine, una prospettiva verso noi stessi, gli altri e la vita del tutto nuove e differenti. Imparare a controllare la nostra emotività, non facendoci da essa travolgere bensì spostare il nostro focus sulle possibili soluzioni anziché sul fallimento e la perdita. La nostra mente è fortemente condizionata a restare invischiata nel problema e nella sofferenza, continuando così a creare dolore e realtà negative. Spostando invece il nostro punto di osservazione potremmo guardare alla difficoltà del momento come ad un’opportunità di migliorare una parte di noi e accrescere il nostro potenziale. Riflettiamoci, ascoltiamoci, perché dentro di noi possiamo trovare le risorse necessarie ad affrontare la sfida e a maturare ad un livello più alto. Non sempre sarà semplice, ma è l’unico modo per vivere attivamente il cambiamento e i momenti di difficoltà che si presenteranno, senza farci totalmente ed eternamente travolgere da essi. Proviamo a ri-cercare in noi stessi un atteggiamento che ci sia di sostegno utilizzando tutta la determinazione che possediamo e che già in passato, a ben pensarci, abbiamo già incontrato e della quale abbiamo beneficiato, per trasformare ciò che, molte volte, deve inevitabilmente essere trasformato. In ultima battuta, ricordiamo anche di imparare a chieder l’appoggio degli altri, amici, parente, rete sociale tutta ed eventualmente un professionista, senza per questo sentirci deboli, falliti o perdenti. Noi ne valiamo la pena sempre. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: appartenere a sé e agli altri aumenta autostima ed autoefficacia
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 27 October 2017
Appartenere a chi? Appartenere a cosa? Ma se mi basto perché dovrei sentirmi appartenente ad altri? Sono molti gli interrogativi che vengono espressi in merito a questa tematica del senso dell’appartenenza. Appartenere ad un gruppo col quale condividiamo valori, bisogni e desideri può decisamente incidere sulla nostra identità personale in primis e conseguentemente sul nostro senso di riuscita ad affrontare le avversità, non solo perché consapevoli delle nostre risorse ma anche perché convinti che il gruppo, o i gruppi ai quali ci aggreghiamo, ci daranno sostegno e riparo. L’identificazione con il gruppo riduce palesemente l’influenza di una svalutazione sociale, Mouna Bakouri nell’articolo pubblicato sul British Journal of Social Psychology conferma che la connessione con il gruppo ha un effetto “tampone” che attutisce l’impatto stressante degli eventi rafforzandone le capacità di coping degli individui e, aggiunge, che il legame di appartenenza non è esclusivamente quello basato sull’identità collettiva (ad esempio etnica) ma può trovare le sue radici anche nell’identità relazionale basata sui rapporti con famiglia e amici. Questo ci conferma che alla base di una appartenenza sociale si crea una maggiore resilienza anche dinnanzi a limiti strutturali esterni (politici, storici, sociali; esempio eclatante la crisi economica dell’ultimo decennio). In definitiva, il senso di appartenenza è sicuramente un sentimento di fondamentale importanza nella nostra vita quotidiana, un legame che si instaura tra individui coscienti di avere svariati fattori in comune: cultura, intelletto, professione, religione e molto altro ancora. Ma va rimarcato il fatto che un senso di appartenenza troppo “dipendente” può portare le persone a dimenticare la propria identità personale, al punto da entrare in simbiosi con l’altro o gli altri, con una sempre più marcata concezione di un noi verso un loro; una mancanza di confini personali verso l’esterno a cui ci si sente appartenenti e allo stesso tempo una mancata capacità di apertura verso tutto ciò che viene considerato diverso e che estremizzato viene escluso a priori. Ecco che collocarsi in una posizione di frontiera, consapevoli e mai in maniera totalizzante, potrebbe preservare il senso di appartenenza a noi stessi, la nostra identità personale senza lesioni all'autostima, senza sentirsi assorbiti, fagocitati dall’organismo di appartenenza e, soprattutto, ricordando di poter rivendicare i propri bisogni, le proprie aspirazioni intellettuali ed emotive senza sensi di colpa, con la consapevole serenità di poter dire NO a ciò che non sentiamo ci denoti o ci appartenga. Rimanere esterni, quel tanto che basta a conservare la nostra indipendenza di azione e di pensiero, mantenendo integri i nostri giudizi ci indica una appartenenza scelta e non totalizzante. Una collocazione di confine certe volta considerata scomoda, impegnativa, faticosa da sostenere e da difendere, poiché chi decide di far propria l'idea di una “recinzione aperta” corre il rischio di essere considerato come uno che ha l’arroganza di preferire la propria opinione a quella altrui. Evidentemente trattasi di una posizione scomoda anche dal punto di vista emotivo poiché non risparmia sensi di colpa e conflitti interiori. Tuttavia, colui che ha il coraggio di scegliere e utilizza ciò che sceglie per aprire nuove strade, per esplorare nuovi territori, per rinnovarsi e rinnovare, può definitivamente considerarsi libero. Libero di scegliere, libero di rifiutare e libero di appartenere. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: sei colori, che a coppie costituiscono tre contrari
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 11 November 2017
Aforismi e citazioni sulla “magia” dei colori e del loro rispecchiamento con le nostre emozioni sono davvero innumerevoli: (V. Kandinskij) “[...] come un grande cerchio, come un serpente che si morde la coda (simbolo dell’infinito e dell’eterno), stanno dinanzi a noi i sei colori, che a coppie costituiscono tre grandi contrari. E a destra e a sinistra stanno le due grandi possibilità del silenzio: del silenzio della morte e di quello della nascita […]. Non poteva di certo mancare, nella specifica rubrica del sabato, una pagina dedicata al magico universo dei colori, chiave d’accesso al proprio mondo interiore, alle proprie emozioni più recondite. Fondamentale strumento per la crescita personale e il voltare una pagina della propria vita grazie alla Arte-Terapia. Citando le parole di R. Sicurelli, un sociologo e psicologo contemporaneo che ha compiuto ricerche antropologiche soprattutto nell'ambito del cosiddetto mondo magico: “la percezione del colore va intesa come un evento rivelatore di una dinamica emozionale profonda, che dipende dalle caratteristiche personologiche del percepiente. In altri termini, la tavolozza cromatica interna dipende non solo dal nostro modo di percepire i colori esterni, ma anche dalla nostra specifica modalità di rivisitare emozionalmente gli stessi”. Siamo costantemente sommersi dal colore, essi fanno parte del nostro linguaggio quotidiano, ci aiutano ad esprimere emozioni, stati d’animo (verde dalla paura, rosso di rabbia…), ci identificano nell’abbigliamento, nell’arredo di case ed uffici e addirittura nella tintura dei capelli e nella scelta del maquillage. Riguardano, decisamente, la nostra sfera più soggettiva ed intima. In base alla tonalità considerata, evocano non solo differenti emozioni ma esprimono anche un’ampia gamma di sentimenti che spaziano da un polo positivo ad uno negativo, abbracciando la complessità dei vissuti emozionali ed esperienziali connessi a un determinato colore. Con i colori, oltre a stimolare il senso della vista grazie a dipinti ed opere d’arte, tra le più svariate, riusciamo spesso anche a descrivere un gusto, un suono. Colori primari che mescolati a modo tra loro, creano i cosiddetti colori secondari; dall’unione di due o più matrici di colore se ne possono originare dei terzi, proprio come dall’unione di una coppia è possibile la nascita di una nuova vita; come con l’amalgama di più ingredienti (il terriccio, l’acqua, la luce, l’aria), possiamo osservare esterrefatti il germogliare di una intera foresta. Pensiamo al susseguirsi cromatico delle stagioni e al significato che ad esso ognuno di noi da’. In sintesi la nostra realtà è decisamente colorata anche se qualcuno potrebbe vederla grigia, pur sempre di un colore si tratta. La scienza ha già ampiamente spiegato che il colore nasce dalla luce, assorbita dagli occhi e tramutata in impulsi per raggiungere il cervello, addetto tecnicamente all’interpretazione di un’impressione cromatica. Ma tanto quanto i colori, anche le emozioni possono definirsi meri fenomeni fisici, entrambi esistono: la luce e la gioia di vivere, entrambi entrano in contatto con l’essere umano e vengono modificati dalla qualità della percezione di quest’ultimo. Ecco perché gli svariati studi di associazione tra colore ed emozione ci indicano, in linea di massima che colori caldi quali il giallo, l'arancione e il rosso sono percepiti in una dualità di aggressività, irrequietezza o come stimolanti e positivi, mentre quelli freddi, ad esempio i violetti, i blu e i verdi sono percepiti come emotivamente scostanti e riservati, piuttosto che tranquilli e sereni. Detto ciò, occorre fare attenzione alla concezione “popolare” dell'associare ai colori cosiddetti vivaci una vivacità emotiva: sta difatti nella relazione tra colore, vissuto interno e storia della persona che si può evincere il significato emotivo soggettivo del colore. Per alcuni studiosi, inoltre, per valutare la risonanza emotiva di un colore occorre valutarlo nei diversi contesti associativi rispetto ad altri colori. I colori, quindi, ricevono il loro contenuto emotivo tramite le relazioni, il contesto, il vissuto soggettivo di ogni persone in cui essi vengono rappresentati. Non dimentichiamoci mai che le relazioni non sono altro che il risultato di esperienze e associazioni del tutto personali, le quali, come nel caso dell’arte espressionistica possono risultare estremamente individuali. Mai dare nulla per scontato. La nostra personale “tavolozza cromatica interna” dipende non solo dal nostro modo di percepire i colori esterni, ma anche e soprattutto dalla nostra specifica modalità di rivisitare emozionalmente gli stessi nel vissuto interno. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: la pigrizia mentale con le sue cause principali può essere indirizzata in maniera positiva
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 20 October 2017
Uomo siesta sombreroIl filosofo R. W. Emerson asseriva: “ è pigro l’uomo che può far di meglio”. In parte concordo con lui ma d’altro canto sono una sostenitrice della pigrizia positiva, quella che concede attimi di riposo mentale e fisico e soprattutto che ci permette di ricordarci che esistiamo e che necessitiamo di cure (intese come mere coccole). Va ovviamente però dato un taglio più energico a tutti colori i quali soffrono terribilmente di senso di colpa per il loro sentirsi o meglio ancora, definirsi, “pigri mentali”. Persone che lamentano dei momenti di passività in cui cercano di evitare ogni minima fatica. Non stiamo trattando nella maniera più assoluta la tematica della depressione in questo preciso contesto, tanto per essere puntigliosi. Ma passiamo subito al focus dell’argomento odierno, le cause della nostra pigrizia potrebbero avere differenti spiegazioni: il non voler affrontare situazioni impegnative per la paura di errare ed essere giudicati (ci risiamo con l’autostima minata); il voler evitare incontri noiosi; la semplice svogliatezza che potremmo imparare a giustificare semplicemente ammettendo che siamo umani e che possiamo avere dei momenti di “downitudine”. Ecco allora una serie di espedienti che potrebbero esserci molto utili. Partiamo da Morfeo, la divinità del sonno. Dormire troppo, dormire troppo poco sono entrambi estremi radicali che non ci permettono una regolarità del ciclo sonno - veglia. Avrai spesso testato su te stesso che sia tu faccia le ore piccole, sia che resti a “fare la panata” girandoti e rigirandoti nel letto per una intera mattinata, proverai quasi sempre un senso di spossatezza che ti impedirà di svolgere al meglio le attività della giornata e inevitabilmente ti farà percepire il tuo agito come pigro. Un’altra buona pratica sarebbe quella di divedere le attività incombenti, frustranti, noiose e apocalittiche, in attività più piccole, ma meno impegnative. Per esempio se dobbiamo pulire la casa non spaventiamoci per il gran lavoro. Organizziamoci dividendo il lavoro per stanze, così l'impegno ci sembrerà meno insormontabile. Questo equivale a visualizzare l'obiettivo prefissatoci, obiettivo realizzabile, pensando ai benefici che avremo dall'aver svolto e non rimandato gli impegni (una maggiore autoefficacia percepita ci potrebbe essere di grande aiuto in questo). Concediamoci delle pause di ristoro fisico e mentale. Bastano anche soli 10 minuti di relax. Non tiriamo troppo la corda e chiediamo aiuto se non ce la sentiamo di fare tutto da soli, chiediamo aiuto a familiari o amici. Evitiamo di rimandare a domani quello che potremmo fare oggi (detto popolare sempre valido). Ritardare i nostri impegni ci porterà ad accumulare impegni su impegni creandoci stress da ansia e molti problemi organizzativi. Piuttosto organizziamo i nostri impegni della giornata e della settimana (impariamo a gestire il nostro tempo). Preparare una scaletta degli impegni giornalieri o settimanali, per avere bene a mente ciò che vorremmo fare e quanto tempo abbiamo a disposizione per organizzarci, potrebbe essere un ottimo piano d’azione. Se proprio non ne possiamo più, infialiamo le scarpette ginniche e facciamo un po’ di moto all’aria aperta, stimolando così sia il corpo che la mente e ricaricandoci di energia nuova. In conclusione, proviamo a riflettere alle conseguenze del nostro non agire. Decisamente è faticoso ed impegnativo e comporta anche una certa dose di assunzione di responsabilità da parte nostra l’agire e il portare a termine i propri compiti, però il non agire può portare a conseguenze spesso ancor peggiori. Pensiamo ogni tanto a queste conseguenze per motivarci ed evitare così di cadere in letargo. Non scordiamo mai però che non siamo dei robot e che non vi è nulla di male nell’oziare ogni tanto semplicemente per stare bene con noi stessi e regalarci attimi di totale relax tra mente e corpo. Spazziamo via il senso di colpa dettato dal fare, fare, fare ad ogni costo e ad ogni prezzo. Vivremo meglio noi e chi ci sta vicino. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: senso del dovere: bye bye. Oggi scelgo il piacere!
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 04 November 2017
Di recente, alcuni clienti, mi hanno fatto notare che non avevano mai pensato a quanto: autostima, senso di colpa e senso del dovere fossero così correlati tra loro. Ebbene sì, un unico groviglio da dipanare senza troppa semplicità ma neanche in maniera del tutto impossibile. E’ proprio il caso di dire: quando il dovere si tramuta in volere. Allora passiamo alla pratica dei fatti su come imparare, giorno per giorno, senza troppe pretese da noi stessi, ad abbandonare i sensi di colpa e del dovere assoluto ritrovando una sana leggerezza interiore. Il marcato senso del dovere, a causa di secoli di retaggio culturale, colpisce maggiormente il sesso femminile, senza escludere però il cosiddetto “sesso forte”. Liberarsi dal mito della brava bambina, della brava mogliettina, non è affatto facile. Cresciute fin da piccole con l'idea di dare il meglio di sé, spesso le donne si trovano in una sorta di limbo, all’interno del quale combattono fra ciò che credono di dover fare e ciò che invece una vocina più intima e nascosta dice loro, vocina connessa ai desideri e ai bisogni più profondi. Ecco perché ascoltare i propri bisogni, privilegiarli rispetto al senso del dovere assoluto e puntare sul piacere e su ciò che ci diverte, può diventare una mera svolta, un cambiamento totale nel modo di affrontare la vita sia dal nostro punto di vista che da quello degli altri! Basta con ansie e angosce da senso di colpa per aver anteposto una volta ogni mille giorni noi stessi agli altri, basta con rimpianti martellanti del genere: “se dico no cosa penseranno mai di me!”. Impariamo ad osservarci, quali insegnamenti ci sono stati trasmessi durante la nostra infanzia? Imparare a guardare dentro noi stessi da prospettive differenti richiede sacrificio e fatica, un vero e proprio allenamento mentale che alla lunga aumenterà con estrema lucidità la nostra consapevolezza. Se fin da piccoli siamo cresciuti in un ambiente dominato dal senso del dovere, ora che siamo adulti può accaderci di sperimentare un profondo senso di colpa all'idea di non seguire le “regole”. Accettare di vedere e manifestare le sensazioni che proviamo a tal riguardo è già un primo passo utile per sbloccarci. Evitare di programmare o fare solo ciò che pensiamo sia giusto e doveroso secondo i canoni sociali e culturali, iniziando di contro a domandarci cosa veramente vorremmo fare con un bel sorriso stampato in faccia, potrebbe essere un ottimo inizio nel cambio di prospettiva attuale. Imparare ad ascoltare i reali bisogni innesca una comunicazione realistica fra noi e ciò che proviamo, tra la nostra mente e il nostro corpo. Una strategia molto utile, al fine di fissare bene in mente quali sono i nostri vorrei al posto degli innumerevoli devo che ci siamo imposti, potrebbe essere quella di trascrivere le cose che amiamo fare e che riescono a darci il buon umore. Una sorta di vademecum dei nostri desideri. Ovviamente tutto questo è una novità per noi e il nostro ormai consolidato modo di pensare e di agire, quindi, inizialmente faremo una gran fatica, diremo dei NO un po’ striduli e anche poco realistici o fin troppo aggressivi, nessun problema, ci stiamo allenando per imparare a fare meglio, quindi accettiamo con clemenza i nostri limiti, senza troppe pretese e aspettative da noi o dagli altri (che faranno davvero fatica a comprendere e accettare questo nostro nuovo essere). E’ dagli sbagli che impariamo le lezioni più dure! Memorizziamo il nostro essere persone nuove nei momenti felici e senza la pressione esagerata del senso del dovere. Ovviamente nessuno asserisce di mollare capre e cavoli senza assunzione di responsabilità alcuna. Nessuno sta asserendo di chiudere gli occhi e fare un drastico salto nel vuoto. Siamo adulti con delle responsabilità sociali, familiari, lavorative ma anche personali verso noi stessi e alleggerire la nostra mente equivale a far star meglio noi e quindi maggiormente predisposti verso gli altri. Ce lo meritiamo. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il “qui ed ora” così lontano eppure tutti ne parlano
Written by Letizia Ciabattoni
Published: 29 April 2017
Rispondo con molto piacere alla richiesta pervenutami via mail qualche giorno fa dal signor F. : “Gentile dottoressa, Potrebbe dare spiegazioni dettagliate del “qui ed ora” così tanto gettonato ma per me non del tutto circoscritto sino in fondo come termine,grazie?”. In effetti, il “qui ed ora” traduzione derivante dalla locuzione latina “hic et nunc”, potrebbe sembrare un déjà vu rispetto a tutte quelle tematiche che si focalizzano sull’individuo e il suo stare nel benessere, una contaminazione temporale di vissuti passati e desideri futuri. Sembrerebbe quasi che d’obbligo sia lo stare con i piedi ben radicati in uno spazio “qui” ed in un tempo circostanziato al “ora”. Nessun obbligo e nessun salto spazio temporale, semplicemente la società, tutta, proietta gli esseri umani sempre più a dei ritmi esasperanti, quasi a volerli far schizzare fuori da delle orbite satellitari precedentemente tracciate, una proiezione verso un dopo lontano incerto e che causa mere ansie e paure da spazio vuoto e pressoché ignoto. Un futuro che pare sia predestinato ad essere esclusivamente per come hai lanciato dietro di te le tue semenze: se hai seminato bene nel passato avrai un roseo futuro, se avrai avuto malauguratamente carestie, pestilenze, nubifragi durante la tua semina passata, con grande probabilità da calcoli aerospaziali, avrai un futuro pessimo, a voler edulcorare la pillola. Tutto questo, caro signor F. per spiegare in soldoni che la maniera meno tossica per il benessere psicofisico e per uno stato di equilibrio stabile o giù di li sta nell’imparare, cosa non sempre facile, a focalizzare la propria attenzione giorno per giorno sul presente, senza rimanere intrappolati, radicati in un passato che bene o male non potrà oltremodo ripetersi ed evitare di vivere totalmente sbilanciati verso un futuro che certamente potrebbe regalare il raggiungimento di obiettivi, di sogni e progetti realizzati, ma col rischio di allontanarsi dalla realtà, dalla costruzione quotidiana di solide fondamenta dalla quali esperire e consapevolizzare. Il passato come un saggio mentore potrà insegnare forse qualcosa ed il futuro come un infante che traballa eccitato lungo i suoi primi passi invoglierà al viaggio ma entrambi, avranno necessità di ristoro e di una base sicura ora, oggi, nel presente del “qui ed ora”. Continui rimpianti o perenni fantasie possono essere alla stregua dannosi. Consapevolizzare la presenza di entrambi è già un passo in avanti verso una stabilità, stabilità che si ergerà dritta e sicura nel presente. Arrovellare la mente in notti insonni per rimediare a ciò che è trascorso o ubriacarsi di progetti a lungo termine, escludendo la possibilità di fallimenti, rivalutazione dei medi obiettivi, potrebbe creare delle aspettative non esauriente, causa spesso di delusioni inaspettate ed ingestibili. Allenarsi al “qui ed ora” è possibile, quotidianamente, potenziando i sensi e lavorando con la respirazione, la concentrazione e la percezione di se stessi. Esisto, percepisco il mio dentro e ciò che mi circonda, sono cosciente del fatto che io scelgo per me e di me. Comincia con lo svolgere una delle tue tante azioni quotidiane abitudinarie in una maniera nuova, differente: cambia l’ordine in cui ti vesti o ti svesti, usa spazzolino, spazzola, cucchiaino con la mano opposta a quella che solitamente usi (destra o sinistra a seconda che tu sia destrorso o mancino), osserva, annusa, tocca e assaggia con lentezza ogni singolo boccone, ogni sorso che bevi, ascoltane anche il rumore che fa tra le dita, nel piatto, in bocca, nel palato. Prova a salire in macchina, se sarai tu alla guida, dal lato del passeggero per poi spostarti al volante, ti sentirai sciocco, in imbarazzo o semplicemente divertito, ma capirai quante cose fai abitualmente senza accorgertene, senza avere il minimo controllo e quindi senza gustare le tue azioni, il tuo corpo che si muove, il tuo respiro. Se sei entrato nell’ottica del gioco prova ad accendere o spegnere le luci in casa col gomito o la spalla, scegli tu. Impara a prendere ogni giorno, solo per te, pochi minuti in un ambiente che ti fa sentire bene e nel quale ad occhi chiusi respiri ed inspiri profondamente con consapevolezza, semplicemente: inspira “il mio corpo è calmo”; espira “sorrido a me stesso”; inspira ancora “sono qui ed ora con me stesso”; espira “il mio momento perfetto”. Prova quando e quanto vuoi, regalati del tempo. Inizialmente potrai aver confusione, resistenze, arriverai in alcuni casi forse anche ad auto sabotare questi attimi solo tuoi, sarà normale, sono le tue difese che hanno paura, fanno fatica a lasciarsi andare, ascoltale, non giudicarle, da loro tempo e soprattutto divertiti. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il senso di colpa è un’emozione logorante, andrebbe ridimensionato
Written by Letizia Ciabattoni Published: 14 October 2017
Mamme che si sentono in colpa se dedicano alcune ore settimanali alla cura del proprio sé, figli che ormai adulti si sentono in colpa per non aver realizzato i sogni dei propri genitori, colleghi che sentono il peso della colpa nell’aver accettato di fare qualche ora di straordinario riscuotendo così a fine mese una paga più corposa dei colleghi. Come ben scriveva John Dryden, poeta inglese della fine del 1600: “Solamente l’uomo ostacola la sua felicità con cura, distruggendo ciò che è, con pensieri di ciò che dovrebbe essere.” Stiamo parlando di un’emozione che ci logora, consuma la nostra autostima (il valore che attribuiamo a noi stessi), l’autoefficacia (la possibilità di interagire con efficacia con il nostro ambiente circostante di riferimento) e la nostra sicurezza. Ci rende inferiori agli occhi degli altri, ci mette nella condizione di mancata percezione positiva di noi stessi. Compare, nell’uomo, verso i 18 mesi di vita, con lo scopo di ricordarci della presenza dell’altro da rispettare e di un codice etico e morale al quale sottostare per il quieto vivere sociale. La colpa, infatti, svolge anche funzione adattiva indispensabile alla crescita personale, all’accrescimento del senso di responsabilità e del dovere e ci permette, se moderata e non patologica, di capire che qualcosa non va, che potremmo aver commesso un errore, ferito qualcuno, permettendoci così di porre rimedio, riparare un “danno” compiuto anche involontariamente, grazie all’esternazione di scuse dovute e comportamenti atti a ristabilire gli equilibri. “Ma allora proprio non vi è via d’uscita, Dottoressa?”, mi è stato chiesto di recente da Anna. Rispondo, cara Anna che si esce dalla spirale del senso di colpa con la consapevolezza e l’accettazione che i propri errori sono spesso e volentieri riparabili. Non possiamo accollarci un senso eccessivo della responsabilità verso noi stessi e l’umanità intera. Non tutto dipende da noi. Non siamo stati eletti a martiri con lo scopo di espiare le colpe proprie e del resto degli abitanti della Terra. Non semplice, visto che gran parte dei nostri sensi di colpa hanno origini nelle interiorizzazioni delle norme che i nostri genitori ci hanno lasciato in eredità. Un grande terapeuta dei primi del novecento, Fritz Perls, sosteneva che: vivendo imprigionati nei propri cliché e nelle norme che regolano la società, l’individuo sviluppa le proprie nevrosi in quanto è come se viaggiasse tentando di tenere sempre bene a mente “ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare”, e non “ciò che vuole e ciò che sente”, rinunciando in tal modo alla propria autenticità. Questo ci fa capire quanto il senso di colpa possa essere considerato come un “forte ostacolo alla piena autorealizzazione di sé”. Ma oltre alla radici genitoriali, sembra anche che l’emozione del senso di colpa sia strettamente correlato con una immagine ideale di se stessi troppo distante dalla realtà e poco realistica. Aspettative troppo elevate che rischiano di non realizzarsi e che non permettono una vera conoscenza di noi stessi in maniera piena e completa. Ecco che alla luce di quanto scritto sino ad ora, possiamo provare a liberarci da questa seconda pelle del senso di colpa capendo innanzitutto se abbiamo realmente arrecato un danno a qualcuno, anche se fosse, magari è accaduto in maniera del tutto involontaria, o se più che altro il senso di colpa che proviamo sia dovuto ad un incresparsi della nostra immagine ideale e al nostro senso del limite: ricordiamoci di essere umani e che come tali possiamo sbagliare e avere dei limiti. Accettiamo la nostra fallibilità, concedendoci di essere più indulgenti con noi stessi in caso di fallimento, provando a circoscriverlo come episodio singolo e non come declino di tutta la nostra esistenza per generazioni e generazioni. Assumerci le nostre responsabilità è doveroso ma convincersi di potere detenere il controllo del mondo intero, essere rigidi e bacchettoni con noi stessi all’inverosimile, non solo ci rende frustarti e perennemente insoddisfatti e arrabbiati, ma ci allontana dalla realtà dei fatti e potrebbe compromettere le relazioni con gli altri, che esse siano di tipo lavorativo o affettivo. Evitiamo, se possibile, di identificarci nel mito di Atlante, punito da Zeus e costretto a tenere sulle proprie spalle l'intera volta celeste. Impariamo a conoscere noi stessi e ad accettare i limiti nostri e quelli altrui. Lasciamo le aspettative elevate al mondo del Fantasy, un mondo ricco di magia e di rinascite degne dell’onirico ma troppo spesso lontano dalla realtà quotidiana. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il mio ordine potrebbe essere visto da te come disordine
Written by Letizia Ciabattoni Published: 22 September 2017
Alzi la mano chi non ha mai sentito il proprio genitore sbraitare, da una stanza all’altra della casa, di mettere in ordine tutto quel disordine in camera, intimando anche una punizione esemplare in caso contrario. Escludendo a priori, in questo contesto, il disordine e l’ordine patologico, ossessivo, possiamo certamente affermare che vi sono molte persone che apprezzano l’ordine ed altre che invece sono disordinate; sono quelle persone a cui non sembra davvero rilevante tenere le cose in ordine. Questo però non significa necessariamente che siano anche persone inclini alla sporcizia, anche se a volte è implicito; il disordine può derivare sia da una mancanza di tempo (cosa alquanto tipica in questi decenni) che da una mancanza di voglia, oppure semplicemente dal fatto che si possa pensare vi siano cose ben più importanti e interessanti dell’organizzare tutto in un “determinato modo”. Entrando un po’ più nello specifico si potrebbe affermare che l’ordine, ad esempio, non segue un modello prestabilito, non esiste una formula scientifica con cui poter valutare se una stanza è in ordine o no; viene considerato ordinato tutto ciò che per la stramaggioranza delle persone “funziona” in maniera organizzata, con lo scopo ultimo di trovare uno spazio, una collocazione ad ogni elemento al fine di potersene eventualmente avvalere in un secondo momento in maniera pre-determinata e anche abbastanza celermente. Quindi, potremmo esemplificare tale concetto con un esempio pratico: una serie di libri, potrebbe non essere catalogata in ordine alfabetico, bensì per un termine di significato fondamentale ed utile per il detentore dei libri stessi, quindi ad esempio per genere letterario, per colore di copertina, per tematica trattata, questo non equivarrebbe ad una libreria disordinata, semplicemente ad una libreria con un ordine differente dalla media, originale, personalizzata. Stessa cosa vale per quelle persone che sostengono fermamente di essere disordinate, eppure, riescono a scovare ogni singolo appunto di carta nel loro disordine. La risposta sta nel fatto che, pare esista una cosiddetta variante al disordine per come lo si generalizza, un disordine considerato ortodosso o ordinato. In questa specie di disordine apparente agli occhi della maggioranza, tutto viene trovato senza alcuno sforzo e senza troppa perdita di tempo, dall’autore di tale disordine. Il problema si innesca nel momento in cui una terza persona interviene e decide di “organizzare tutto quel marasma”, la persona “disordinata ortodossa” di cui parlavamo prima, si vedrà totalmente neutralizzata nel ri-trovare le cose, poiché il suo “ordine disordinato” le è stato alterato in maniera definitiva. Questo, in conclusione, ci indica che l’ordine (escludendo quello patologico), è soggettivo. Così come sono differenti le persone, i loro sistemi di classificazione mentale, le loro personalità, anche il sistema organizzativo è differente. Vi sono priorità e modi di vivere distinti, non escludendo che ciò che funziona per una persona debba funzionare per un’altra. Quindi, imparare a tollerare e rispettare chi è organizzato e organizza le cose attorno a se in maniera differente dal nostro non sarebbe affatto una cattiva abitudine, anzi, potrebbe essere l’inizio di un nuovo modo di accettare un punto di vista differente dal nostro, una grande chance, dalla quale si potrebbe anche imparare a conoscere molto di più di se stessi. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: la timidezza come punto di forza da valorizzare
Written by Letizia Ciabattoni Published: 07 October 2017
Mi capita che alcuni clienti si lamentino del loro essere timidi, introversi: “dottoressa, arrossisco anche dal panettiere sotto casa, ma si può? Mi sento uno stupido. Si figuri con le ragazze o con il mio capo, neanche riesco a dire una parola, arrossisco e chino il capo.”, mi scrive Eugenio. Il fatto è che normalmente tendiamo a pensare alla timidezza come un lato di noi del tutto negativo, da estirpare come si fa con la gramigna in un campo di grano. La difficoltà a mantenere gli occhi negli occhi, mani sudaticce, respiro affannoso, palpitazioni a mille, le guance, le orecchie, il collo che si infiammano e la saliva in bocca pare venga meno e non riusciamo più a spiccicare una mezza parola. Se non si tratta di un vero e proprio disturbo d’ansia sociale, sarebbe molto importante accettare il fatto che la timidezza non è altro che un lato della propria personalità che, esattamente come l’estroversione, ha i suoi vantaggi. Riuscire a rivalutare ogni caratteristica delle persone timide in un’arma per il successo, anche se sembra difficile è fattibile. In prima istanza le persone timide risultano essere dei grandi osservatori poiché colgono, spesso e volentieri, aspetti di una conversazione che altri normalmente non colgono. Inoltre l’essere timido non è sinonimo di solitari o asociali. Questo aspetto è stato confermato anche da uno studio nel quale è stato rilevato che i bambini che a 18 mesi mostravano un temperamento timido, all’età di 3 anni avevano migliori abilità di cogliere la mente degli altri. Spesso, le persone timide sono più riflessive, creative e stimolano maggiormente il loro pensiero critico. Essere riflessivi permette, in molti casi e in molti campi, di prendere decisioni in maniera adeguata, a pensare prima di agire o parlare, evitando quindi fraintendimenti e situazioni spiacevoli a livello sociale. Come negare che i timidi sono degli ottimi ascoltatori e per questa loro dote risultano molto empatici, ottime qualità per tutte quelle professioni di contatto con gli altri. Di fronte a una persona che sa ascoltare, in genere, ci si sente accettati e felici di avere comunicato con lui. Inoltre, i timidi spesso appaiono meno “minacciosi” di altri e ciò li rende socialmente più accessibili. In aggiunta, gli studi hanno dimostrato che i comportamenti dovuti al nervosismo (agitazione, sudore, rossore…) potrebbero essere legati all’alto funzionamento mentale della persona. Le ragioni neurologiche di ciò non sono ancora del tutto chiare e vi sono diverse spiegazioni in merito, nessuna definitiva. Vi è ad esempio la teoria del sovraccarico cognitivo, la quale ritiene che quando abbiamo a che fare con pensieri o problemi complessi tendiamo a scaricare il sovraccarico cognitivo tramite il movimento, liberando quindi risorse mentali per il ragionamento e l’attività mentale. Ad ogni modo, ciò che potrebbe essere a prima vista interpretato come impaccio, non sempre è quello che sembra. Per ultimo ma non per questo meno importante, i timidi, gli introversi, tendono a stabilire relazioni amicali profonde e durature. A questo punto credo che dover superare la timidezza ad ogni costo non sia poi cosa del tutto necessaria. La timidezza diventa un mero problema solo quando interferisce con la nostra vita, portandoci ad evitare le relazioni o ad avere difficoltà sul lavoro, parliamo in questo caso estremo di fobia sociale. In tutti gli altri casi, trattasi di un aspetto del funzionamento umano che ha numerosi vantaggi (leggi sopra) che assolutamente andrebbero coltivati e accolti serenamente. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: specialità del giorno gelosia o invidia, quale gradisce?
Written by Letizia Ciabattoni Published: 15 September 2017
Davide mi scrive: “io non capisco se le persone attorno a me sono geloso o invidiose. Personalmente non credo di essere geloso di nessuno, forse un tantino invidioso delle persone che lavorano poco e guadagnano molto e non devono far grossi sacrifici alla fine del mese. Decisamente sì, quelle persone le invidio davvero molto. Sarò mica l’unico al mondo!?”. Le somiglianze tra le due emozioni, gelosia e invidia, sono molte e spesso hanno una derivazione sociale e non personale. Alla base potrebbe essere celata una mera “crisi” di autostima a livello di confronto sociale. La gelosia è in noi presente sin dalla prima infanzia, viene spesso accettata maggiormente rispetto all’invidia, poiché giustificata come l’altra faccia dell’amore: gelosia da bambini verso le proprie figure genitoriali, verso oggetti particolarmente significativi, sino ad arrivare alla gelosia provocata da eventi che minacciano la propria vita di coppia. Alla base della gelosia vi è la paura di perdere il possesso, che esso sia un bene, un oggetto o una persona a noi cara. E proprio come le altre emozioni, anche la gelosia può essere attivata da pensieri inerenti circostanze esterne e/o immagini mentali e ricordi. Per eccellenza conosciamo la cosiddetta gelosia romantica, quella provata per una persona che si ama e che si teme di perdere, la quale si sviluppa in un triangolo a tre: il Sé (la persona gelosa), la Persona Amata e il Rivale. Secondo D’Urso (2013), tale tipologia di gelosia si innesca per via di determinate convinzioni: 1) la convinzione che alcune relazioni si configurino come oggetto di possesso e diano il diritto di richiedere o vietare determinati comportamenti (persino di vietare, in modo paradossale, sentimenti e desideri); 2) Il timore che il Rivale voglia o possa insidiare il possesso e il godimento della Persona Amata provocandone la perdita parziale o completa; 3) la previsione che se ciò dovesse accadere la persona gelosa ne avrebbe un danno, una sofferenza per la perdita dell’oggetto d’amore o della sua esclusività, e una ferita all’immagine di sé. Questo tipo di gelosia è, molto spesso, accompagnato da paura, tristezza, rabbia, vergogna e da un calo dell’autostima. Vi sono però anche altri tipi di gelosia, quelle rivolte ai figli, ai fratelli, agli amici, tutte verso un soggetto, una persona d’amore a noi cara. Dicevamo inizialmente che la gelosia però, viene maggiormente tollerata rispetto all’invidia, un’emozione anch’essa complessa che fa riferimento ai valori e all’immagine di sé. In particolare, alla base dell’invidia si riscontrano sentimenti di mancanza, di rivalità e senso di inferiorità. Si può quindi definire l’invidia come un sentimento di malessere verso un’altra persona, o un gruppo di persone, le quali, dal punto di vista dell’invidioso, posseggono qualcosa che lui non ha e che vorrebbe ad ogni costo. È quindi “necessaria” la componente della rivalità con l’altro per il possedimento di un oggetto o una condizione, senza la quale ci si sentirebbe inferiori, minacciati nella propria immagine personale e sociale. Ma quindi, provare invidia, denota aspetti positivi o negativi? Secondo diverse ricerche (Castelfranchi e Parisi 1988), l’invidia ha come fulcro l’ostilità: chi non consegue uno scopo desiderato soffre vedendo che gli altri invece sono in grado di raggiungerlo e prova ostilità per chi gli causa questa sofferenza. Le emozioni correlate all’invidia possono variare da: il disprezzo, la rabbia, l’ammirazione, la svalutazione di sé, l’indignazione, e la vergogna. Essa può indurre ad azioni aggressive espressamente dirette a danneggiare la persona invidiata. Viceversa, vi può anche essere un atteggiamento passivo in cui si rinuncia a lottare per il bene invidiato e prevale un generale senso di sfiducia in se stessi e di autocommiserazione. Tuttavia, secondo altri autori, vi sarebbero accezioni positive dell’invidia, una invidia cosiddetta “buona” che porterebbe la persona ad auto migliorarsi a seguito della percezione della propria mancanza nel confronto con l’altro. Ricapitolando, gelosia e invidia sono entrambe emozioni spiacevoli, a tratti penosi che implicano una diminuzione dell’autostima. Nello specifico: la gelosia è più frequente quando nel confronto sociale una nostra qualità viene minacciata; l’invidia è più frequente quando l’individuo si confronta con chi possiede in maggiore grado una qualità, un bene o una condizione rilevante per l’individuo invidioso; la gelosia nasce frequentemente nell’ambito dei rapporti affettivi, essenzialmente per timore di perdere la totalità o l’esclusività di un legame affettivo, mentre l’invidia riguarda prevalentemente il rapporto con i beni o con condizioni di successo, di potere, di status; la gelosia è spesso accompagnata da stati mentali di sospettosità, sfiducia, auto svalutazione, paura, ansia e rabbia, ipersensibilità alle frustrazioni ma anche amore e desiderio verso la persona di cui si è gelosi; l’invidia invece, nasce dalla percezione di una mancanza nei confronti dell’altro, ed è spesso accompagnata da senso di inferiorità, acuto senso di possesso, desiderio di danneggiare l’altro, anche se può essere presente ammirazione e una spinta positiva a emulare chi si invidia. Ora, sta a noi decifrare le nostre emozioni ed imparare a gestirle, accettandole al fine anche di tramutarle in qualcosa di positivo e costruttivo per il nostro progetto di maturamento personale. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: che tipo sei? Sempre in anticipo o un iper ritardatario?
Written by Letizia Ciabattoni Published: 30 September 2017
Arrivare troppo in anticipo ad un appuntamento potrebbe risultare altrettanto da “maleducati” e poco organizzati, ansiosi, tanto quanto essere in perenne ritardo. Che sia un appuntamento con amici, la visita dal ginecologo o la revisione periodica dell’auto, il tempo, pare, non scorra in egual misura per tutti noi. Qualcuno percepisce un’ora come composta da 77 minuti, altri, come se un’ora equivalesse a pochi secondi. Pare che anche le culture di appartenenza diano una bella sferzata di soggettività allo scorrere delle lancette dell’orologio. Termini quali: “poco prima, verso, intorno alle ore…” di certo non ci aiutano a stabile una tabella oraria unanimemente condivisa, ma allora come far conciliare gli appuntamenti tra un ritardatario ed un puntuale? Probabilmente entrambi dovrebbero scovare degli escamotage reciproci. Troppo puntuali, parliamo di quindici minuti se non di più, ad ogni costo, alla stregua, potrebbero essere campanellini d’allarme per persone che vivono una notevole ansia da prestazione, da stress del dovere ad ogni costo. Persone che vivono con la sveglia puntata una mezzora in avanti, vivendo perennemente nel continuo senso di ritardo e del tempo che sfugge al loro controllo. Parliamo di persone che vivono così nella perenne, o quasi, attesa degli altri, cosa che evidentemente rischia di farle innervosire, fomentando ulteriormente la dose di stress e frustrazione quotidiana. Allo stesso tempo, chiunque abbia un appuntamento con un iper puntuale, entra in tensione poiché sa che comunque vada non sarà mai abbastanza puntuale o in anticipo il giusto necessario e verrà di conseguenza mal giudicato. Sarebbe importante che i puntualissimi si concedessero un po’ più di relax e che evitassero di calcolare in maniera quasi ossessiva ogni eventuale imprevisto possibile ed inimmaginabile. Si potrebbe provare con degli esercizi di lentezza, tramite visualizzazioni guidate, oppure riorganizzando la propria agenda e depennando tutti quei minuti dedicati ad eventuali contrattempi, regalandosi così il lusso di arrivare puntuali almeno nelle situazioni cosiddette informali. D’altro lato, i ritardatari, sempre di corsa e con mille intoppi tra una visita medica e l’orario di lavoro, potrebbero soffrire di una specie di timore di rimanere “soli” in una sala d’aspetto vuota o all’angolo del bar, come una sorta di ansia d’abbandono, non sapendo bene cosa farsene del tempo in esubero da trascorrere con loro stessi. Potrebbe essere utile portare con sé una rivista, un libro, della musica da ascoltare o riordinare l’agenda. Allo stesso tempo varrebbe sempre il pratico consiglio di compilare giornalmente una lista degli impegni presi, eliminando quelli non indispensabili, anticipando gli orologi e le rispettive lancette, di almeno cinque minuti, pianificando prima i tempi e i modi per realizzare ciò che si deve fare. Sarebbe importante ricordare a se stessi che la puntualità, oltre ad essere un buon bigliettino da visita personale, è anche una dimostrazione di rispetto verso gli altri e una forma di praticità, poiché permette di acquistare i biglietti del cinema senza doversi accontentare delle ultime file e doversi subire code estenuanti ai botteghini, inoltre, la puntualità allenta le tensioni cardiovascolari e mentali del dover inventare mille scuse e l’affanno nel cercare parcheggio e salire le scale a due a due per evitare di non arrivare in ritardo sul ritardo. In definitiva, la “retta” via sta nel mezzo. Dare la giusta importanza al proprio tempo e a quello altrui è davvero una mera forma di rispetto per se e per gli altri. A questo punto sarebbe molto utile che tra loro, i puntualissimi e i ritardatari si supportassero a vicenda, facendo capire, gli uni agli altri le sensazioni che si provano e quello che si desidererebbe attenuare o far maturare nell’altro. Nessuno è perfetto ma ognuno può maturare consapevolmente. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: accettare la perdita di chi amiamo
Written by Letizia Ciabattoni Published: 09 September 2017
Partire dal presupposto che dare una connotazione di “evento modificabile se solo avessimo fatto, detto, deciso..” non ci è di grande aiuto, accettando, anche se con molta resistenza, l’irrimediabilità dell’accaduto può permetterci di riorganizzare i nostri cuori in frantumi. Purtroppo, il dolore del lutto si differenzia da quello provocato ad ogni altro tipo di perdita per intensità e per la sua totale definitività, alla quale non è possibile rimediare in alcuna maniera (Pangrazzi, 1991); lutto comporta, quindi, la necessità, in prima istanza di accettare la perdita. L’accettazione è un processo che, per definizione, implica la tendenza al rifiuto, intendendo con rifiuto il desiderio del soggetto di credere che la perdita non si sia verificata (Perdighe, Mancini, 2010). Trattasi sempre di un processo impegnativo da dover affrontare e superare, a prescindere dagli eventi che hanno determinato la perdita e dal soggetto spirato. Abbiamo già altrove evidenziato quanti possano essere le innumerevoli situazioni di lutto: di un genitore, del proprio partner, di un amico, del proprio animale domestico ma lutto è anche una separazione, un divorzio, un licenziamento o il dover abbandonare le proprie mura casalinghe a causa di una calamità naturale o per un trasloco definitivo. Ovviamente i livelli di intensità variano in maniera soggettiva da persona a persona, dal vissuto individuale e dal legame di attaccamento avuto con l’oggetto o il soggetto del lutto stesso. Il processo di elaborazione viene, solitamente, suddiviso in quattro fasi. Non si tratta di una suddivisione rigida e le caratteristiche di una fase possono, di frequente, ripresentarsi anche nelle fasi successive. Nella prima fase può manifestarsi uno stato cosiddetto di calma apparente, determinata dalla negazione della realtà e dalla soppressione delle emozioni; questo stato potrebbe avere fine solo nell’atto in cui la persona che ha subito la perdita si sentirà in una situazione abbastanza sicura da potersi lasciare andare emotivamente. Nella seconda fase, si potrebbe sperimentare la rabbia, con una mera ricerca fisica dell’oggetto perduto (il soggetto spera che la persona amata e perduta ritorni) e una ricerca cosiddetta psicologica (si rimuginano in modo ossessivo gli eventi che hanno condotto al distacco). Si verifica spesso che si speri di poter ritrovare chi si è perso, agendo come se la perdita non fosse mai avvenuta; si tratta di una dinamica finalizzata a negare la realtà, troppo dolorosa da accettare. In un secondo momento, quando comincerà a farsi strada la consapevolezza dell’inevitabilità del distacco, potrà subentrare la collera per l’abbandono subito; la rabbia è fondamentale per la ristrutturazione interna della persona che ha subito la perdita. La terza fase comporta disorientamento, vuoto, solitudine: la perdita sottrae, insieme alla persona amata, il legame affettivo con la persona perduta. L’ultima fase è caratterizzata da una scarica emotiva utile all’accettazione di qualcosa che non si può modificare. Non si può far altro che accettare la sensazione di vuoto, di solitudine estrema o il desiderio di piangere quasi in maniera ininterrotta, tutte sensazioni sane, normali e utili ad elaborare ed esternare il proprio vissuto interiore, da non confondere affatto come espressività di una patologia. Tentare di rimuovere il dolore, soffocandolo negli impegni quotidiani o evitando di parlarne potrebbe essere una strategia non sempre adeguata. Le complicazioni del processo di accettazione del lutto potrebbero nascere nel momento in cui si tratterà la perdita come una questione ancora aperta, suscettibile di cambiamento. Evidentemente vi sono dei fattori che potrebbero incidere sulla mancata accettazione della perdita e quindi della mancata capacità elaborativa dello stesso. La gravità: tanto più la perdita è significativa tanto più comprometterà la realizzazione riuscita di proseguire nella quotidianità; la mancanza di sostegno sociale: non avere una rete di aiuto parentale, amicale, significa non avere persone che possano fornire supporto, una spalla su cui piangere il proprio dolore e sostituirsi, almeno parzialmente, alla persona perduta, oltre al potersi avvalere del sostegno di “altri significativi” con cui parlare della perdita e di non sentirsi giudicati in tal senso (spesso capita, nei casi di perdita di animali domestici considerati meri membri della famiglia, di non sentirsi a proprio agio nel poter sfogare il proprio dolore per paura di venir soggiogati o non compresi). In conclusione, il passaggio “canonico” tra le fasi di elaborazione o le difficoltà possibili e riscontrabili sono essenzialmente una mappa che non descrive il singolo territorio di ognuno di noi, ecco perché il rispetto del dolore, delle diverse credenze culturali che spesso affrontano ed elaborano la morte con tutt’altre modalità rispetto a quella considerata ad hoc, e della specificità dell’individuo stesso sono fondamentali. Come fondamentale resta, a parer mio, accompagnare le persone in un momento così delicato, con un occhio alle risorse personali e alla cultura familiare e sociale di provenienza e appartenenza. Non è detto, ad esempio, che “piangere” o “deprimersi” sia un passaggio sempre obbligato, così come spesso accade che non si arrivi mai alla fase di accettazione, senza per questo che il lutto resti irrisolto e che si debba intervenire per paura di conseguenze o intoppi futuri nel benessere psicofisico della persona. Non mi resta che condividere una meravigliosa citazione di F. Kafka: “quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.” Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il nostro livello di autostima può essere migliorato
Written by Letizia Ciabattoni Published: 02 September 2017
“Buongiorno dott.ssa, ho trovato i Suoi post sull’autostima cercando in rete. Ho 29 anni ormai, e sono stanca di sentirmi insicura di tutto, incapace e non sicura di me stessa, ma non riesco a cambiare..da anni penso che con l'età arriverà anche la sicurezza, ma cavoli, non sono più una adolescente!!! Se capisce cosa intendo dire! Ringrazio. Sonia.” Come ci fa ben notare Sonia, un basso livello di autostima può rappresentare un enorme ostacolo nel percorso verso il raggiungimento dei nostri sogni e obiettivi. Quando smettiamo di credere in noi stessi, nelle nostre potenzialità e nelle nostre capacità, permettiamo al mondo esterno che ci circonda, di prendere decisioni al nostro posto, decisioni che spetterebbero soltanto a noi. La buona notizia è che il livello di autostima di ognuno di noi non è insito nella nostra genetica come il colore degli occhi o l’altezza, la bella notizia sta nel fatto che si è sempre in tempo ad imparare a rispettarsi, accettando i propri limiti e soprattutto apprezzando i propri pregi. Non ci resta altro che mettere a frutto alcune azioni pratiche da poter svolgere quotidianamente in maniera efficace per aumentare il proprio livello di autostima. Partiamo dalle basi, curiamo noi stessi, il nostro aspetto. Ovviamente preferiamo di gran lunga l'essere all'apparire, ma curare noi stessi, il nostro aspetto fisico ed il modo in cui ci vestiamo, può avere un importante impatto sulla nostra autostima. A volte, quando ci sentiamo giù di corda e fuori forma, un po’ di attività sportiva, una bella doccia, uno smalto nuovo e un filo di trucco o un nuovo dopobarba ed il nostro capo di vestiario preferito, possono rivelarsi dei veri e propri toccasana per aumentare la fiducia in noi stessi. Impariamo a definire i nostri obiettivi. Non lasciamoci avvilire da quei periodi della vita in cui ci sembra di incappare in continui capitomboli e fallimenti. Ripensiamo alle cause, molteplici, di tali fallimenti: la dannata sfortuna (molto meno di quanto crediamo), la nostra mancanza di auto-disciplina (spesso, ma non sempre), gli inevitabili ostacoli che non avevamo preventivato. Eppure, spesso non riusciamo a centrare i nostri obiettivi a causa del modo in cui li definiamo. Ricordiamo che obiettivi migliori, possono condurci a risultati migliori e di conseguenza, ad una maggiore autostima. Ripensiamo al modo in cui pensiamo a noi stessi. Ricordiamoci che in gran parte, il livello di autostima è legato all’immagine che proiettiamo di noi stessi nella nostra mente. Non sempre questa immagine è reale, anzi, troppo spesso tendiamo a dare maggior peso ai nostri difetti piuttosto che ai nostri pregi. Questa immagine non è incisa in maniera indelebile nella pietra, può essere modificata totalmente, lavata via con un colpo di spugna. Questo non equivale a mentire a se stessi, ma al contrario, si tratta di equilibrare, anzi: ri-equilibrare i nostri pregi e i nostri difetti. Impariamo a prendere la buona abitudine a parlare lentamente, poiché il nostro corpo e la nostra gestualità influenzano la nostra mente e viceversa. Un esempio? Proviamo a parlare lentamente perché, chi parla in modo fermo e pacato, dimostra molto di frequente, di avere piena padronanza dell’argomento e di non doversi precipitare per esprimere la propria opinione. Infine, prendiamo la sana abitudine di scrivere un diario personale in cui ricordiamo i nostri successi, le nostre emozioni, i nostri pensieri (positivi e negativi) quotidiani, con lo scopo di aiutarci ad avere un’immagine più oggettiva dei risultati che abbiamo raggiunto nel passato. Abitualmente memorizziamo i fallimenti, i pianti, le paure in maniera maggiore rispetto ai successi e ai divertimenti. Abitudine alquanto malsana. Conoscersi, ri-conoscere quello che abbiamo già affrontato ed il modo in cui ne siamo usciti, può essere una spinta fondamentale per aumentare la fiducia e conseguentemente l'autostima. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: fidarsi è un bene, non fidarsi non saprei!
Written by Letizia Ciabattoni Published: 05 August 2017
Nel momento in cui ci fidiamo di un altro, ci aspettiamo inevitabilmente qualcosa di buono da lui, di poter contare su questa persona, nonostante non ne abbiamo alcuna certezza, poiché, non potremmo mai essere sicuri di cosa farà davvero. Ma allora perché tendenzialmente ci fidiamo di alcune persone mentre di altre no? Le motivazioni principali possono essere racchiuse nel seguente elenco: ci aspettiamo che le persone possano darci ciò di cui abbiamo bisogno; condividiamo valori e ideali con le persone fidate; abbiamo notato dei risultati, da parte delle persone che riteniamo degne della nostra fiducia, confacenti ai nostri ideali; ci fidiamo delle persone che si comportano come noi e che si identificano con le nostre stesse regole comportamentali o regole della fiducia. Ma d’altro canto perché è così difficile fidarsi di determinate persone o di determinate circostanze? Semplicemente perché abbiamo paura di rimanere delusi. Sentirsi traditi nelle proprie aspettative fa male, è deludente perché non ci permette di ottenere quel buono che ci saremmo aspettati e ne soffriremo. Quindi, non essere del tutto certi , non avere garanzie dell’atteggiamento dell’altro ci crea paura, sofferenza, titubanza. La questione si accentua nel momento in cui abbiamo bisogno degli altri per raggiungere qualcosa di importante. Più la posta in gioco è alta e più facciamo fatica a fidarci. Spesso non ci fidiamo degli altri perché non crediamo di avere degli interessi che ci accomunano, temiamo di venir sfruttati, usati, manipolati, fregati dall’altro. All’opposto invece ci fidiamo ciecamente di tutte quelle persone che ci dimostrano il loro amore, il loro affetto. Il motivo alla base è molto semplice: pensiamo che amandoci, desiderino il meglio per noi, desiderino la nostra felicità. In soldoni, ci fidiamo più dei risultati, dei comportamenti delle persone che delle persone in sé. Ci fidiamo fin tanto che le nostre aspettative non vengono deluse. Parliamo quindi di fiducia “condizionata”, la quale si basa sul cosa gli altri fanno e come lo fanno. Ci fidiamo perché abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri, poiché gli affidiamo alcuni incarichi importanti. L’altro tipo di fiducia, quella “incondizionata” si connota per il suo nascere in base a ciò che le persone sono. Proviamo a chiederci se ci fidiamo delle persone per come sono in senso lato o per come si sono sempre comportati con noi e le nostre potenziali aspettative. Forse è arrivato il momento di consapevolizzare che le cose che ci aspettiamo dagli altri sono una nostra responsabilità; che tutte le emozioni che proviamo dipendono da noi e dal nostro vissuto; dobbiamo imparare a fidarci di noi stessi prima ancora che delegare agli altri la nostra felicità o il raggiungimento di tali obiettivi. Se dipendiamo dagli altri, pretenderemo tanto, troppo da loro, col rischio che non sempre le persone sapranno o vorranno assecondare i nostri bisogni. Ecco allora che soffriamo, ma non per come siamo stati trattati, bensì per come ci aspettavamo che l’altro si sarebbe dovuto comportare secondo la nostra personale visione delle cose. Ma allora fidarsi è bene o no? Se amiamo la persona di cui ci fidiamo dovremmo pensare che essa possa essere la migliore versione di se stessa, dovremmo credere nel suo potenziale infinito. Fidarsi non equivale però ad essere ciechi, ingenui ed imprudenti. Potremmo asserire che la fiducia verso se stessi e verso gli altri equivale a credere nelle proprie ed altrui potenzialità; credere che i nostri e gli altrui errori siano recuperabili e che domani sarà meglio di ieri; ricordare che siamo fatti di limiti, paure, debolezze ma anche di risorse immense e troppo spesso inutilizzate. Chiedere aiuto, non equivale a delegare la nostra vita agli altri. Farsi dare una mano è ben diverso dal far dipendere la propria vita dalle scelte altrui. Impariamo a fidarci di noi stessi, delle nostre potenzialità e a quel punto potremo, con prudenza, fidarci degli altri e delle loro potenzialità. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il rispetto per se per gli altri si chiama ASSERTIVITA’
Written by Letizia Ciabattoni Published: 25 August 2017
Molti miei clienti lamentano una grossa difficoltà nel dire no ai loro partner, al capo, all’amico e persino al nemico. Nulla di nuovo, in verità, basta riflettere sul luogo comune che, da decenni ormai, si tende a valutare una persona in grado di far rispettare i propri bisogni, con garbo ed educazione ovviamente, come un soggetto egocentrico, arrivista, poco propenso all’altruismo, insomma, un personaggio alquanto spregevole. Errato! Comunicare i nostri bisogni e le nostre esigenze, apprendere nozioni, creare o “distruggere” rapporti di amicizia e di amore, emergere nel mondo del lavoro, esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni, sono tutte cose possibili grazie ad una sana e corretta comunicazione. Imparando ad utilizzarla bene, può diventare una nostra alleata e può permetterci di vivere meglio e di avere rapporti più sereni ed equilibrati; se la usiamo male invece, può diventare una nostra nemica e procuraci litigi, conflitti, dolori. Ma comunicare bene, significa anche saper ascoltare non solo l’altro ma anche se stessi. La comunicazione, dal latino cum-munire, in realtà significa "comunicare con", nel senso di far conoscere, mettere in comune, fare partecipe l'altro, e implica reciprocità. Senza dimenticare che quando comunichiamo utilizziamo sia il nostro corpo tramite i gesti, la postura, le espressioni facciali (componente non verbale) sia il linguaggio attraverso la voce (componente verbale) e il suo ritmo, volume e timbro (componente paraverbale), trasmettendo quindi sia le informazioni, il contenuto del messaggio ma anche le emozioni annessi ad esso. Va da sé che è necessaria, per una buona comunicazione, una buona conoscenza di se stessi, una corretta e profonda conoscenza di cosa si desidera, la consapevolezza di come ci si sente nell’atto di entrare efficacemente in contatto con gli altri. Ma quindi l’obiettivo cardine sta non solo nel trasmettere e codificare un messaggio, bensì nella possibilità di poter affrontare con maggior serenità i rapporti interpersonali, di ridurre l'ansia sociale, di aumentare la fiducia e la sicurezza individuali. Robetta da poco, insomma. Ed ecco che, a questo punto, potremmo servirci dell’assertività, vale a dire essere rispettosi verso sé e verso gli altri, essere consapevoli dei propri pensieri, dei propri sentimenti, avere stima e considerazione per sé e per gli altri, riconoscere i propri limiti e le proprie virtù. Il fatto è che a volte sembrerebbe più “easy” comunicare con l’esterno che con se stessi, col risultato di non sentirsi compresi, frustrati, accusando spesso l'altro del disagio che proviamo, attribuendogli una mera incapacità comprensiva se non addirittura la mancanza di un interessa sincero verso il nostro eloquio. Altre volte invece, capita che si è ben coscienti di ciò che si pensa e si prova, ma non si è pronti a dire la verità a se stessi e agli altri per paura di risultare aggressivi, egoisti, offensivi, inappropriati. Ed ecco che a questo proposito si denota un filo conduttore tra l’assertività e l’autostima. Le persone con una capacità comunicativa e comportamentale assertiva posseggono, solitamente, una buona autostima e una positiva considerazione di sé, sono consapevoli di se stesse e sanno cosa vogliono dalla vita, cosa le renderebbe felici. Le persone che si esprimono con una comunicazione passiva o aggressiva invece negano molto spesso i sentimenti propri a favore di quelli altrui, rifiutano i complimenti perché non si sentono degni di riceverne o ancor peggio credono di venir presi in giro, rinunciano ai propri bisogni, evitano di fare scelte, non si assumono i rischi del cambiamento, si auto-svalutano costantemente e soffrono di bassa autostima, ovviamente. Ormai pare chiaro che vi sia una relazione inversamente proporzionale tra aggressività/passività e realizzazione di se, perché si rischia di suscitare negli altri risposte altrettanto anassertive, mere “fabbriche di produzione in catena” di sentimenti di rabbia, frustrazione, tristezza, competizione. Proviamo ad indicare i contesti in cui viene maggiormente messa a dura prova la nostra capacità di esprimere liberamente ciò che sentiamo e di cui necessitiamo e ciò che non condividiamo. I contesti lavorativi, familiari ed amicali sono dei campi minati in tal senso. Un capo che approfitta del proprio ruolo assumendo il ruolo di comandante anziché di leader. Un partner che ci chiede di assecondare ogni sua richiesta, di seguirlo/a in mare piuttosto che in montagna sapendo bene quanto noi odiamo l’una o l’altra meta. Dei figli esigenti ventiquattro ore su ventiquattro, ottantacinque anni su ottantacinque. Sarebbe forse opportuno correre ai ripari. Secondo Salter (psicologo e psicoterapeuta statunitense) potremo cercare di allenarci in maniera tale da essere assertivi nei seguenti modi: esponendo i nostri sentimenti, cercando di non sottovalutare le espressioni della nostra faccia e di quella degli altri, iniziando a parlare utilizzando il pronome “Io”, provare ad essere contenti quando riceviamo un complimento in base al nostro valore attribuito da noi stessi, riuscendo ad improvvisare e tentando di sostenere un contraddittorio. In sostanza, si potrebbe iniziare col guardarsi allo specchio e vedere un’immagine positiva di noi stessi, così da riuscire, un po’ per volta, a superare ogni genere di timore. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: il tuo tempo non ha prezzo. Parola di Counselor!
Written by Letizia Ciabattoni Published: 18 August 2017
Seneca asseriva: “Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono, di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla”. Il tempo: troppo poco, troppo ricco, troppo vuoto, pieno di impegni, molto noioso o dilatato all’estremo. Relativo questo tempo che se godi vola via, mentre nella sofferenza e nell’attesa sembra non voler scorrere più. Un tempo che ci sfugge di mano quando si tratta di dedicarlo a noi o alla famiglia e che il lavoro ci consuma quasi totalmente. Sempre in ritardo o forse gli altri troppo in anticipo. Tutto ciò sta alla nostra percezione soggettiva, spesso fonte di stress e insoddisfazione. Ciò che più conta è il modo in cui viviamo il tempo. La nostra mente attribuisce un senso al tempo, lo riempie, lo svuota di significato, di valori e di ricordi pieni di sentimenti. Viviamo il tempo tridimensionale: passato, presente e futuro. É la relazione che instauriamo con esso che ci condiziona, che determina la nostra capacità di essere più o meno efficaci, al punto da poter arrecare disturbi al nostro benessere psicofisico. Proviamo ad essere più espliciti: vivere nel passato, esserne prigionieri, è tipico degli stati malinconici e depressivi, nei quali non c’è nessuna capacità di immaginare l’avvenire. In questi stati viene meno l’orizzonte della vita, rimaniamo bloccati in situazioni antiche che si ripetono, senza possibilità di imparare dall’esperienza pregressa e senza essere in grado di determinare un cambiamento di vita. Nessun passato ha senso, senza un presente a cui fare riferimento. Il futuro invece è il territorio del desiderio e della speranza, ma anche di stati emotivi quali l’ansia e l’angoscia che si sviluppano in relazione all’imprevedibilità dell’avvenire, l’intolleranza dell’incertezza, l’incapacità di sopportare la possibilità che nel futuro si possano verificare eventi inattesi e incontrollabili. Nessun futuro è auspicabile, senza un solido presente dal quale progettare. E cosa possiamo dire in merito al presente? Chi lo vive, solitamente è ancorato alla realtà, “adeguato”, equilibrato. Non radicato nel passato e tanto meno proiettato al futuro. In grado di godere del “qui e ora”, senza alcun tentativo di sfidare eccessivamente il tempo, non vi si oppone, non lo contrasta né anticipandolo, né arrestandolo in ogni maniera. L’opposto di chi afferma che 24 ore son troppo brevi, di chi vive perseguendo un attivismo estremo, che vuole fare tutto, farlo bene, possibilmente da solo, senza delegare o chiedere aiuto a nessuno, vivendo la frenesia come mero stile di vita. Tale approccio alla quotidianità rischia di condurre spesso le persone a stati di frustrazione cronica, senso di inadeguatezza, nervosismo ed irritabilità, pigrizia, senso di vuoto o ansia quando si ha del tempo, troppo tempo libero, oltre a svariati sintomi somatici come disturbi gastrici e digestivi, mal di testa, cali di pressioni improvvisi, disturbi del sonno. Impariamo allora ad accettare che il tempo, in quanto risorsa, è limitato e che l’importante sta nel gestirlo il più serenamente possibile. L’ossessione del fare, non ci fa sentire le emozioni, ci fa evitare il contatto con noi stessi e rischia di far si che restiamo solo sulla superficie delle cose, senza davvero mai chiederci come stiamo e cosa proviamo. Di fronte a questa ansiosa corsa all’occupazione del tempo la soluzione sta nel rallentare, prendersi delle vere pause, attendere, prendersi cura di se. Un cambiamento di approccio alla vita quotidiana non facile da realizzare, in una società che ci spinge alla “sindrome da bulimia del tempo”. Allora proviamo a esercitarci sull’attenzione del presente, la cui forma più intensa sta nella meditazione. Riappropriamoci della nostra serenità, iniziamo a dirottare l’attenzione da ciò che è esterno verso il nostro interno. Affidiamoci a un professionista che può supportare la nostra ri-organizzazione del tempo tramite tecniche di visualizzazione guidata, grazie alla progettazione di una agenda di vita il cui focus è la persona e il suo benessere. Le possibilità sono innumerevoli, basta prendersi il giusto tempo. Non è mai troppo tardi per vivere meglio. Parola di Counselor!
Counseling con Ciabattoni Letizia: muovi le gambe, che la testa respira
Written by Letizia Ciabattoni Published: 12 August 2017
“Come sono stata bene dottoressa. La vacanza con tutte quelle passeggiate tra i boschi e la notte il silenzio del cielo stellato. Se penso allo stress che mi ritroverò in fabbrica al rientro dalle ferie, mi vien da piangere. Vorrei che le vacanze non finissero mai”, mi scrive Marta da San Benedetto del Tronto. Nulla di più evidente. L’attività fisica, svolta con regolarità, produce innumerevoli effetti benefici sia sui nostri corpi che sulle nostre menti e conseguentemente, inficia sul nostro buonumore e benestare. Che si tratti di camminate, nuotate, pedalate in bicicletta, il movimento regolare, preferibilmente all’aria aperta, immersi nella natura, è un tocca sana. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo sport, se praticato senza eccessi e con regolarità, può prevenire e alleviare i sintomi dell'ansia e dello stress, contribuendo anche a rilassare le tensioni muscolari e a combattere l’insonnia. Tutto questo in parte è possibile grazie al rilascio delle endorfine, i cosiddetti “ormoni del buon umore”, sostanze chimiche di natura organica prodotte dal nostro cervello, dotate di proprietà fisiologiche simili a quelle della morfina e dell'oppio, di tipo analgesico ed eccitante, in grado di regolare l'umore. Durante situazioni particolarmente stressanti, ad esempio, il nostro organismo cerca di difendersi rilasciando autonomamente le endorfine, le quali ci aiutano a sopportare meglio il dolore ed influiscono positivamente sullo stato d'animo. La notizia del millennio è che facendo attività sportiva, il nostro organismo viene stimolato nel produrre questi meravigliosi ormoni, i quali, entreranno in circolo nel corpo, regalandoci molti benefit gratuitamente. Ma non finisce qui, come mi scrive Marta, in merito allo stare bene in vacanza grazie al movimento sano e al relax, fare regolare attività fisica migliora la fiducia in se stessi. Prefissarsi dei piccoli obiettivi da raggiungere, come ad esempio arrivare alla fine del lungomare, fare un paio di rampe di scale a piedi senza l’ausilio dell’ascensore, fare spesa ed andare in ufficio pedalando tutti i giorni, sono obiettivi, che, per quanto piccoli, aiutano a sentirsi più capaci e più fiduciosi nelle proprie possibilità di raggiungere delle mete. Gli obiettivi da porsi devono ovviamente essere rapportati alle possibilità della persona. Il movimento dovrebbe essere vissuto come un momento di piacevole svago da dedicare a se stessi. Detto ciò, cominciamo da quello che siamo in grado di fare e che ci piace fare, evitiamo le esagerazioni e le sfide impossibili in stile “survivor”. Basta davvero poco, mezzoretta al giorno. La parte più difficile sarà quella di iniziare. Se continueremo a trovare delle scuse, proviamo a pensare cosa davvero ci impedisce di svolgere attività fisica. Cerchiamo di capire se preferiamo una attività in solitaria, magari perché andare in palestra ci crea dei problemi nel sentirci osservati o semplicemente per indisponibilità economica momentanea. Una corsetta o una pedalata nel parco del quartiere potrebbe essere un’ottima alternativa, in questo caso. Potrebbe capitare di sentirsi in colpa per una giornata di pigrizia o per altri motivi, non importa, non deve essere un lavoro a tempo pieno, evitiamo di sentirci esageratamente in colpa per questo. Piuttosto, valorizziamo i risultati ottenuti e pianifichiamo nuove strategie per proseguire. Potremmo concederci dei giorni alternati di pausa tra una corsetta e l’altra. Potremmo allentare il ritmo o la distanza da percorrere. Tutto dovrebbe farci sentire piacevolmente in sinergia con il nostro corpo e la nostra mente. Fare qualcosa per noi stessi equivale a considerarsi abbastanza importanti da concederselo. Parola di Counselor!